Pubblichiamo il capitolo IX del libro Weltordnungskrieg1 di Robert Kurz, inedito in Italia, nella traduzione di Samuele Cerea.
Ecco la prima parte.
Abstract:
La crisi del diritto è solo uno dei molteplici livelli su cui si
manifesta la crisi complessiva della modernità capitalistica. La crisi
degli Stati nazionali nel processo della globalizzazione coincide con
la crisi della possibilità regolative degli apparati statali sui
rapporti sociali all’interno e, soprattutto, con una crisi
fondamentale del diritto internazionale, ossia della regolazione del
rapporto tra gli Stati. Un aspetto quest’ultimo drammaticamente
evidenziato dalle guerre dell’ordine mondiale, condotte dagli USA
sotto l’amministrazione Bush: la costruzione pericolante del diritto
internazionale classico non viene sostituita da un nuovo nomos
giuridico ma dalla legge del più forte. Robert Kurz analizza questo
processo di deriva anomica sia all’interno che all’esterno dello
Stato, facendo riferimento alla categoria schmittiana dello stato di
eccezione e al costrutto dell’”homo sacer” di Agamben. Secondo Kurz la
dicotomia stato normale/stato di eccezione, uno dei cardini del
pensiero schmittiano, si risolve, nella società della merce,
nell’alternativa tra uno stato di eccezione coagulato (la cosiddetta
normalità) e uno stato di eccezione fluido mentre la forma-diritto,
kantianamente modellata sulla soggettività moderna del denaro e del
valore, contiene in sé il nucleo della riduzione dell’uomo a “homo
sacer” nel senso di Agamben, liquidabile in ogni momento se superfluo
per la logica del valore.
Parte prima:
La fine del diritto, lo stato di eccezione globale e il nuovo «homo sacer»
Quando la sovranità si dissolve, si dissolve necessariamente anche ogni relazione giuridica e contrattuale tra gli Stati. Questo fatto mette in discussione la forma più generale del moderno diritto borghese, anche nelle relazioni interne ad ogni singolo Stato. Tuttavia questo significa solo che il nucleo autentico di violenza (e in un certo senso anche di arbitrio, per quanto mai totalmente privo di codificazione) del moderno sistema produttore di merce e della forma giuridica si manifesta in tutta la sua evidenza. Decisivo per questa nuova qualità della crisi sistemica è che il potere egemone, nel tentativo di conservare con qualsiasi mezzo la validità universale del suo principio di realtà, invece di difendere la forma giuridica, infrange sistematicamente il diritto stesso, conducendo così all’assurdo la categoria della forma-diritto come tale, che altro non rappresenta se non la relazione formale tra i soggetti feticistici.
Nello sviluppo attuale dopo l’11 settembre è possibile osservare questo carattere della prassi imperiale in una forma duplice e contraddittoria nella sistematica «degiuridificazione» sul piano internazionale. Da una parte l’«imperialismo complessivo ideale» democratico ha costituito un sedicente «tribunale mondiale», subito celebrato apologeticamente dall’orda mediatica, nella figura del tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra all’Aja, che dovrebbe rappresentare ufficialmente il nómos della vecchia «comunità degli Stati», compendiata nell’ONU, ma che in realtà ne manifesta solo la degenerazione ed è in ogni caso una parodia della sua stessa ambizione.
Questa degenerazione è, in primo luogo, giuridica, perché i processi contro Milosevic e i suoi amministratori si fondano su di una rottura palese e neppure troppo negata della Carta delle Nazioni Unite, ossia sulla guerra di aggressione della NATO contro il relitto della ex-Jugoslavia. E anche la consegna di Milosevic al tribunale dell’Aja, alla fine di giugno del 2001, da parte del governo serbo di Djindjic, un burattino della NATO, si basava su di un’altrettanto netta violazione del diritto e della costituzione. Nonostante che il decreto di consegna dell’ex-presidente fosse stato sospeso dalla Corte costituzionale jugoslava solo qualche ora prima, Djindjic non fece nulla per impedire che la non-persona Milosevic venisse sequestrata con un’operazione segreta, spiegando inoltre che il parere del tribunale supremo era «inefficace e privo di valore», che rappresentava addirittura il tentativo di «mettere a repentaglio il futuro del paese». Alla fine Djindjic è stato defraudato della taglia per la consegna di Milosevic, e questa è una prova ulteriore del fatto che si era trattato di una transazione fra violatori del diritto e degli accordi (al di sotto del livello giuridico si dovrebbe parlare di una trattativa tra lestofanti).
Per nulla turbata da queste macroscopiche infrazioni del diritto la stampa liberale ha commentato la vicenda in questi termini: «A Belgrado si è data ben poca importanza alle sottigliezze giuridiche; ma del resto anche Milosevic si atteggiava allo stesso modo, nel periodo in cui fu al potere, quando il diritto doveva adeguarsi alle necessità politiche contingenti» (Neue Zürcher Zeitung, 30/6/2001). Si osservi con attenzione la logica che sottende questa affermazione: nessunissima obiezione al fatto che l’Occidente, proprio come le sue creature nelle regioni della crisi, si comporti secondo modalità che invece vengono rimproverate ai mostri della crisi, che proprio per questa ragione si vorrebbe processare. In nome del principio capitalistico del diritto questo stesso principio viene gettato alle ortiche come un ferrovecchio.
Secondariamente, questa degenerazione è anche morale: non c’è capo di Stato al mondo che, di fronte a capi di accusa come quelli rivolti contro Milosevic, non verrebbe trascinato con la forza di fronte al tribunale dell’Aja, a cominciare da tutti gli amici e fedeli alleati della NATO nella periferia mondiale, dalla Turchia all’Afghanistan, dal Nordafrica all’America Latina. Per il massacro di My Lai in Vietnam né il presidente americano dell’epoca, né il suo Capo di stato maggiore, furono costretti a discolparsi, tantomeno di fronte a un tribunale dell’ONU. E neppure i capi di Stato europei o australiani compariranno davanti ad un tribunale per i crimini contro l’umanità commessi dai loro apparati nei confronti dei profughi. Questa lista potrebbe proseguire indefinitamente.
Da questo complesso di circostanze è possibile trarre un’unica conclusione logica: il tribunale dell’Aja è una sorta di tribunale segreto dell’imperialismo democratico, del tutto privo di legalità e di legittimità. I magistrati che vi esercitano le loro funzioni non difendono affatto il diritto internazionale, ma si auto-degradano a sgherri corrotti degli USA e della NATO. All’innegabile violenza e all’arbitrio dei dispotismi della crisi e dei principi del terrore non si contrappone il diritto ma la sua violazione e quindi, ancora una volta, violenza ed arbitrio. Sia sul piano giuridico che su quello morale, l’imperialismo democratico si colloca sullo stesso livello dei criminali di guerra e dei terroristi, come testimoniano anche i metodi brutali della sua prassi.
Dall’altra, gli USA, con una decisione contraddittoria sul piano formale, ma che nella sostanza si armonizza alla perfezione con l’instaurazione del tribunale segreto internazionale dell’Aja, si rifiutano categoricamente di trasformare questo tribunale in una Corte di Giustizia Internazionale permanente a tutti gli effetti, cui sarebbero obbligatoriamente sottoposti de jure anche i loro governi, ufficiali e soldati. Nel maggio 2002 il Congresso americano ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione «che nega qualsiasi sostegno finanziario a un tribunale permanente delle Nazioni Unite competente per i crimini di guerra e per i crimini contro l’umanità. Viene inoltre proibito al governo statunitense di collaborare con il tribunale, anche solo nella fase inquirente. La sola idea che qualche soldato americano debba piegarsi ai capricci (!) della comunità internazionale ci appare intollerabile – ha dichiarato il presidente del Congresso, il repubblicano Tom DeLay» (Neue Zürcher Zeitung 11/5/2002).
Detto altrimenti: è ammissibile solo un tribunale segreto della democrazia mondiale che giudichi caso per caso regimi e capi di Stato sgraditi e i loro criminali di guerra, conformemente alle esigenze di legittimazione dei poteri dominanti e a discrezione degli USA, non certo una Corte internazionale permanente con regole vincolanti per tutti. Gli USA si comportano come un califfo, che ha il potere di decapitare a suo piacimento chiunque, senza il timore di soccombere alla minaccia che esso rappresenta per gli altri.
Naturalmente, in questo caso, viene alla luce ancora una volta l’insuperabile contraddizione tra particolarismo ed universalismo, tra l’esigenza di un «tribunale internazionale» e la pretesa di una «sovranità nazionale» assoluta. Ma la posizione degli USA a questo riguardo va ben al di là del tentativo di destreggiarsi alla bene e meglio tra queste istanze contraddittorie: è la rottura immanente con la «volontà generale» in quanto tale, cioè con l’universalità astratta su cui si fonda tutto il diritto moderno, ma che è ormai impossibile da realizzare sul livello globale. Una pretesa giuridica, che rifiuti espressamente la validità universale, non è più tale nel senso della forma moderna del diritto; d’altro canto però non è neppure possibile ritornare, in un modo o nell’altro, a rapporti giuridici premoderni. Si tratta cioè della non-forma di un’assoluta assenza di diritto, di uno «stadio supremo dell’anomia», che non fu mai possibile neppure sotto califfi e imperatori divini.
Questa circostanza è così evidente e incontrovertibile che la condotta dell’amministrazione statunitense avrebbe dovuto suscitare un ondata di sdegno da parte del facile moralismo di tutti quegli ideologi, giornalisti e politici, sempre pronti a stracciarsi le vesti di fronte alle malefatte di un Milosevic o di un Saddam Hussein e ad avvalorare più o meno seriamente l’interpretazione per cui la crisi capitalistica mondiale esigerebbe «interventi umanitari» e «guerre giuste». Invece l’unica reazione è stata ed è tuttora un tiepido dibattito relativistico sulla questione del tribunale internazionale, caratterizzato da estrema cautela e ipocrite concessioni, che fa trapelare ogni sorta di «comprensione» nei confronti della rottura americana, non con questo o quel contenuto particolare del diritto, ma con la forma del diritto come tale – un atteggiamento analogo a quello riservato alle gesta efferate dei giovani killer democratici e razzisti, in quel caso con paternalistica condiscendenza dall’alto, nel caso degli USA con deferente «comprensione» dal basso. Come cucciolotti mugolanti, che scrutano con occhiate timorose il bastone che il padrone si porta sempre appresso, i capi di governo dei paesi europei subalterni della NATO, si limitano a vestire i panni di una pusillanime «coscienza critica», che se giudicasse la condotta degli USA conformemente alla loro autocomprensione non potrebbe fare altro che valutarla come un’autentica aberrazione.
È evidente che il discorso ufficiale accompagna il processo di anomizzazione democratica nella sua incontenibile caduta libera, senza che sia più possibile azionare alcun freno. Herfried Münkler descrive questa dinamica con un tenore singolarmente positivistico, come se a scuotere le fondamenta dell’attuale sistema mondiale non fossero proprio i suoi stessi custodi: «Mentre gli europei mirano a sviluppare ulteriormente il diritto internazionale vigente e a adeguarlo alle nuove condizioni della politica mondiale, gli americani stanno iniziando gradualmente a voltargli le spalle. Ne è un chiaro sintomo il loro rifiuto di partecipare alla costituzione di un sistema giudiziario internazionale che persegua i crimini di guerra […]. La via europea consiste nel tentativo di ripristinare i presupposti minimali e irrinunciabili della simmetria politica, invece quella americana si è ormai incurvata verso l’asimmetria nelle relazioni. Gli europei tentano di stabilizzare l’edificio, ormai traballante, del diritto internazionale, nato in Europa, mediante tutta una serie di misure riparatrici; al contrario, per gli americani questa costruzione non può più essere salvata in alcun modo […]. Se gli USA proseguiranno sulla strada che hanno imboccato, sferreranno certamente il loro attacco all’Irak, che era stato risparmiato nel 1991, anche in virtù degli effetti della sopravvivenza dello Stato iracheno sulla stabilità della regione. Sarà il colpo di grazia per l’attuale diritto internazionale. E non ne esiste un altro che possa subentrare al suo posto. Non verrà sancita nessuna eguaglianza di principio ma, come dimostra l’idea della guerra giusta, una marcata asimmetria» (Münkler 2002).
Münkler non allude solo al fatto che la «posizione europea» sia ostinatamente conservatrice, reazionaria, in ultima analisi priva di prospettive ed inoltre inerme e subalterna. Piuttosto egli assume la posizione statunitense in maniera preventivamente affermativa, come se fosse destinata inevitabilmente a imporsi: le cose non possono che andare così. In quest’ottica l’atteggiamento di Münkler è sistematicamente orientato verso una falsa sdrammatizzazione dei fatti, come se in gioco ci fossero solo differenze nella strategia, che potrebbe andare in una certa direzione oppure in una diversa, cosicché, in ultima analisi, saranno gli USA, in virtù della loro superiorità sulla società globale, ad indicare la «retta via». È chiaro che ad imporsi qui è la cieca assuefazione intellettuale al potere dei fatti sul terreno presuntivamente eterno dell’ontologia capitalistica. La differenza tra «simmetria» ed «asimmetria» nel diritto statale ed internazionale, che Münkler descrive in termini eufemistici, è in realtà una differenza fondamentale: in gioco non c’è la via verso «un nuovo diritto internazionale» ma il collasso del diritto internazionale stesso, persino, più in generale, del moderno principio del diritto.
Questa «asimmetria» non rappresenta semplicemente uno squilibrio di potere tra Stati – di per sé tutt’altro che un fenomeno nuovo – ma la fine della possibilità di stipulare accordi e quindi dei rapporti contrattuali come tali. Effettivamente è impossibile concludere un accordo con un’organizzazione come Al-Qaeda, oppure con un folle omicida o un attentatore suicida, poiché essi non sono più soggetti giuridici. Ma questi post-soggetti a-giuridici rappresentano l’elemento costitutivo di ogni diritto e specialmente di tutto il diritto moderno, cioè la forza, che si scatena proprio nella dissoluzione della forma-diritto. L’asimmetria nel rapporto tra soggettività giuridica e violenza anomica si rovescia nell’asimmetria del rapporto tra i soggetti giuridici stessi, che in questo modo non sono già più tali. L’impossibilità di realizzare un rapporto contrattuale con Al-Qaeda si converte nell’incapacità generale da parte degli USA e dell’imperialismo complessivo ideale di instaurare rapporti contrattuali con il mondo degli Stati e anche al proprio interno.
Il fatto che questo sviluppo si prenda gioco di ogni ordinamento giuridico, rimanda al collasso delle relazioni della riproduzione sociale che stanno alla base dei rapporti giuridici stanno crollando. Esiste certamente tutta una serie di livelli di mediazione tra la «superfluità» socio-economica di una percentuale in continuo aumento della popolazione mondiale, i processi della globalizzazione negativa, la manifestazione degli spettri terroristici della crisi e lo sgretolamento della forma-diritto. Ma poiché la moderna forma-diritto è legata al sistema-feticcio del lavoro astratto e della valorizzazione del valore e la soggettività giuridica in generale può essere solo un elemento secondario della soggettività del lavoro e della valorizzazione, essa si estinguerà necessariamente assieme a quella.
Dove non è più possibile stipulare contratti di lavoro, non è più possibile stipulare alcun genere di contratto. Questo stadio non viene raggiunto quando anche l’ultimo lavoratore ha perso il lavoro, ma in una fase più precoce della crisi mondiale, quando una parte sufficientemente grande dei membri della società diviene superflua, mentre quelli che restano vengono posti in una condizione anomica. Tale stadio si generalizza, in primo luogo, sul livello del diritto statale ed internazionale. Collocandosi in una relazione asimmetrica con il resto del mondo sul piano giuridico, per sconfiggere gli inafferrabili poteri anomici, generati dal sistema globale di crisi, gli USA si trasformano a loro volta nella punta di lancia dell’anomizzazione globale.
A partire da questa constatazione è possibile trarre la conclusione critica, emancipatoria per cui è necessario sostituire la forma-diritto borghese, insieme con le strutture del mercato e dello Stato, con un’altra forma di organizzazione delle relazioni riproduttive su scala planetaria, che non necessiti più dell’espressione giuridica di una forma feticistica; in alternativa non si può far altro che prendere apertamente partito per la violenza anomica, nella misura in cui essa è quella ufficiale, ovvero quella dell’imperialismo complessivo occidentale. Non esiste una terza opzione; la spazzatura retorica a base di diritto internazionale, comunità degli Stati, diritti umani, cittadinanza etc. si dissolve perché la forma di riproduzione socio-economica su cui essa si fonda è ormai insostenibile.
Una tendenza che emerge con chiarezza tanto maggiore presso gli ideologi democratici, quanto più essi restano confinati in modo dogmatico e irriflesso nel sistema globale dominante, ontologizzando la sua struttura formale. Le contraddizioni possono essere elaborate solo mediante una fuga in avanti, che consiste nell’aperta esaltazione della rottura violenta col diritto, a patto che venga messa in atto dalla «parte giusta». A questo scopo il costituzionalista Ulrich Preuss, che dopo il suo magniloquente sermone biblico sull’11 settembre non si pone più alcun problema di misura, ci offre un’argomentazione appropriata. Di recente il nostro Preuss, un liberale progressista che da decenni si atteggia a sacerdote liberale dell’illusione giuridica, ha fatto una scoperta straordinaria: non è sempre possibile andarsene in giro con il codice sotto il braccio. Non fatica a riconoscere che non esiste giustificazione alcuna sulla base dei criteri giuridici, perlomeno per gli interventi militari in Kosovo e in Afghanistan, ma in quanto arci-democratico e partigiano fanatico dell’ideologia illuministica non può far altro che approvarli dal più profondo del cuore, assieme con i loro danni collaterali.
Con la sua straripante fraseologia decurtata circa diritti umani, costituzione, garanzie giuridiche etc. – che fa ciecamente astrazione dal moderno sistema della merce come costituzione formale del diritto stesso – il feticista borghese del diritto si vede perciò costretto a convertirsi ad un’interpretazione decisionistica: per giustificarne la sostanza, nonostante la violazione giuridica, la pioggia di bombe della macchina militare statunitense, va considerata come «un ibrido tra legittima autodifesa, esecuzione forzata di un ipotetico mandato di arresto nei confronti di Bin Laden e intervento umanitario per la liberazione del paese dall’infausto regime talebano» (Preuss 2002).
Ma se questo fosse vero, allora anche le vittime del colpo di stato militare cileno del 1973 (anche in quel caso l’11 settembre) e della successiva dittatura sarebbero autorizzate a bombardare senza indugio Washington e qualsiasi altra regione degli USA, visto che di quel sovvertimento politico il governo americano può essere considerato a buon diritto lo spiritus rector; oppure la polizia, alla ricerca di qualche criminale in fuga, potrebbe benissimo mettere a ferro e fuoco interi quartieri; infine ogni singolo paese sarebbe praticamente legittimato ad intervenire in qualsiasi altro, dal momento che il concetto di «regime infausto» è passibile di una certa elasticità. Anche a prescindere dal fatto che quel particolare «regime infausto» era stato precedentemente installato dagli USA.
In ultima analisi, per un verso o per l’altro, tutti i regimi sono «infausti», non da ultimo le democrazie dell’imperialismo della sicurezza e dell’esclusione; e sotto questo aspetto il regime statunitense si trova addirittura in testa alla classifica: dove mai potrebbe essere più urgente un intervento umanitario se non in un paese che incarcera alcuni milioni dei suoi cittadini in condizioni inumane, spesso a causa di crimini irrisori, affidandoli ad un’«industria della pena» che condanna a morte minorenni e malati psichici, per poi trasmettere la procedura in diretta televisiva?
L’ipergiurista Preuss si sbarazza senza indugio della legalità a favore di ciò che egli chiama «legittimità». Anche astraendo totalmente dal contenuto davvero ripugnante di questa cosiddetta legittimità, essa non può più essere ricondotta sotto il tetto della legalità da nessun ordinamento giuridica. E allora è Preuss a «decidere»: «Non fu solo la spinta dell’indignazione morale per il crimine mostruoso dell’11 settembre che spinse gli USA a percorrere la “via diretta” della forza militare nella lotta contro il terrorismo e per la liberazione dell’Afghanistan da un regime scellerato: fu necessaria anche la sfida immediata che era stata lanciata contro l’interesse nazionale statunitense. Facciamo addirittura un passo in avanti: siamo assolutamente certi che in questa vicenda motivi umanitari e cosmopoliti, diretti a rendere il mondo un posto generalmente migliore, abbiano giocato un ruolo marginale. Ma è proprio questa l’amara lezione che dobbiamo imparare: per far trionfare la ragione e la giustizia sono stati necessari il puro e semplice interesse nazionale degli USA e la spontaneità del sentimento morale dei suoi cittadini (Preuss, op. cit.).
In termini più espliciti: evviva il linciaggio globale, che nella terra del Signore può già vantare una lunga tradizione alle sue spalle. O altrimenti: giusto è ciò che gli USA ritengono possa tornare loro utile; «ragione e giustizia» coincidono con il «sentimento morale spontaneo» di soggetti della concorrenza assetati di vendetta e carichi di aggressività, ma solo nel caso in cui questi, incidentalmente, possano contare sulla più spaventosa macchina militare della Terra. O in forma ancora più essenziale: il diritto è «il sentimento morale» dei più forti; in ultima istanza: la forza è il diritto. Così facendo Preuss ha davvero messo allo scoperto le radici del diritto, approdando dalle parti di Carl Schmitt, il demone della scienza giuridica, che riconduce logicamente il diritto al potere di decidere sullo stato di eccezione. Non a caso una monografia sull’evoluzione della filosofia del diritto di Schmitt, reca come titolo «Legittimità contro legalità» (Hoffmann 1964).
E una volta perduta la legalità, comunque neppure più necessaria, Preuss concede il suo beneplacito anche per l’estinzione di quelle vite umane, di per sé inessenziali per il solo fatto che non si tratta delle vite occidentali-bianche-illuminate dei membri di tutte le «sensibili democrazie dell’Occidente» (Preuss, op. cit.): «In ogni caso è pressoché inevitabile che siano anche e soprattutto (!)persone innocenti a perdere la vita e a subire dei danni […]. Non sempre l’uomo può sottrarsi a questi tragici conflitti. Chi crede di poter vivere la propria esistenza con le mani linde e immacolate, tanto più se si tratta di un’esistenza da politico, si abbandona ad un’illusione puerile» (op. cit.).
Così parlò il democratico (un epiteto che in futuro, probabilmente, servirà a biasimare una particolare depravazione morale e intellettuale), lo stesso che solo poco tempo prima, una volta riavutosi dai «primi istanti di paralisi del terrore», aveva manifestato tutto il suo «sconcerto» per l’«ingiusta punizione» inflitta ai cittadini statunitensi dalla cecità terroristica. In ultima analisi tutti i giuristi sono terribili giuristi.
Con le sue mani da burocrate dell’atrocità, ormai tutt’altro che immacolate, Preuss chiama tutto questo un’«amara lezione», forse perché, da buon giurista, la perdita dell’illusione giuridica lo infastidisce un tantino. E una volta abbandonato il regno del diritto, non cerca rifugio nell’aperto cinismo, ma nella teologia del male, poiché, come è noto, nella guerra contro il male tutti i mezzi sono leciti. Poiché le azioni terroristiche sono «blasfemia» e quindi si collocano in una dimensione religiosa, la violenza della polizia globale non può sottomettersi a nessuna restrizione giuridica formale. Una volta ottenuta la legittimazione teologica, non è più possibile azionare alcun freno.
Il moralista del diritto borghese non può che trasformarsi nel trombettiere della Jihad democratica. Morte e dannazione eterna agli infedeli, ai blasfemi! Laddove le condizioni necessarie per la struttura sociale si eclissano, si manifesta il tribunale teologico contro gli eretici. Anche per gente come noi il giudice dell’inquisizione democratica Preuss ha già allestito il rogo, poiché chi non si pone incondizionatamente dalla parte del «bene» (cioè la comunità dei bombardieri democratici), può essere solo un’incarnazione del «male» e deve essere perseguitato con tutta la forza della «legittimità» e del «sentimento morale spontaneo».
Senza attendere il consenso del nostro giurista dalle velleità teologiche, gli USA si sono già strappati di dosso da soli tutte le opprimenti catene del diritto nella loro lotta contro il male. Il veemente rifiuto di una Corte internazionale permanente, con regole vincolanti per tutti, fin da subito ha una ragione oggettiva: le truppe statunitensi erano appena sbarcate in Afghanistan e già venivano accusate di crimini di guerra: «Nel frattempo i soldati dell’esercito statunitense sono stati accusati, non solo di avere torturato e ucciso prigionieri talebani, ma anche di essere coinvolti nella scomparsa di circa 3000 uomini nel campo di Masar-i-Sharif» (Le Monde diplomatique, settembre 2002).
Su questo argomento l’autore e giornalista televisivo britannico Jamie Doran ha girato un documentario e registrato alcune testimonianze circa l’assassinio di prigionieri rinchiusi all’interno di container: «Un tassista della zona si stava dirigendo verso un distributore provvisorio su di una strada extraurbana. “Mentre trasportavano prigionieri da Kalai Zeini a Shiberghan, stavo facendo il pieno alla mia automobile. Sentivo uno strano odore e allora domandai al benzinaio quale ne fosse l’origine. Guardatevi attorno – fu la sua risposta. Vidi allora tre container da cui uscivano fiumi di sangue. Mi si rizzarono i capelli sulla testa, era tutto assolutamente spaventoso […]”. Il giorno successivo lo stesso tassista si trovava nei pressi della sua casa a Shiberghan e poté assistere ad una scena non meno terrificante: vidi altri tre container, da cui il sangue colava a pioggia, che passavano accanto alla mia casa”. Non a tutti i prigionieri rinchiusi nei container le pallottole avevano dato il colpo di grazia. La maggior parte sopravviveva al suo destino per quattro, cinque giorni, fino alla morte per soffocamento, per fame o sete. Quando finalmente il container si aprì, di tutti suoi occupanti era rimasta solo una massa raccapricciante di urina, sangue, feci, vomito e carne in decomposizione […]. Mentre i container, con il loro carico di carne umana, se ne stavano allineati davanti alla prigione, uno dei soldati che avevano accompagnato il convoglio seppe che il comandante della prigione aveva ricevuto l’ordine di far sparire immediatamente tutte le prove. “La maggior parte dei container presentavano fori di proiettile. In ognuno di essi c’erano circa 150-160 morti. Un paio respiravano ancora, però per la maggior parte erano morti. Gli americani dissero ai loro collaboratori a Shiberghan di farli sparire dalla città prima che fossero filmati dai satelliti”. Questa testimonianza, che fa riferimento a un coinvolgimento degli statunitensi, sarà decisiva per tutte le indagini future» (Doran 2002).
Altre testimonianze raccontano del coinvolgimento di dozzine di soldati delle «forze speciali» in crimini ripugnanti, torture e uccisioni di prigionieri indifesi, ovviamente sotto l’impulso del «sentimento morale spontaneo» dopo l’11 settembre: «In un caso un soldato afghano racconta di aver visto un soldato americano uccidere un prigioniero talebano al solo scopo di impaurirne un altro affinché confessasse: ero di servizio a Shiberghan e ho visto un soldato americano spezzare il collo a un prigioniero. Un’altra volta hanno versato sui prigionieri dell’acido o qualcosa del genere. Gli americani facevano tutto quello che volevano. Non potevamo impedirgli di fare alcunché […], tutto era sotto il controllo dei comandanti americani. Un generale dell’Alleanza del Nord che in quel periodo si trovava a Shiberghan ha dichiarato: “Sono stato testimone. Ho visto come li colpivano alle gambe, tagliavano loro la lingua, i capelli, la barba. A volte sembrava che si divertissero. Portavano fuori un prigioniero, lo picchiavano e poi lo riportavano in cella. Qualche volta il prigioniero non ritornava più”. Tutti i testimoni apparsi nel nostro film si sono già detti pronti a comparire davanti ad una commissione di inchiesta internazionale o in un processo giudiziario, nel caso in cui, in seguito alle loro affermazioni, dovesse scaturire qualcosa. Inoltre sarebbero anche in grado di identificare i militari coinvolti» (Doran, op. cit.).
Ma fino ad oggi queste accuse assai concrete sono state completamente ignorate dalla maggior parte della stampa occidentale e bloccate dagli apparati imperiali. Si confronti questa assenza di sensazionalismo a differenza di quanto accaduto per le atrocità vere o fasulle, perpetrate dall’esercito di Milosevic in Kosovo o dai serbi nella famigerata Srebrenica. Evidentemente ci sono due tipi di atrocità: quelle degli «infedeli», trascinati dalla loro «blasfemia», e quelle della parte giusta, quella di «ragione e giustizia», sospinta dal «sentimento morale spontaneo». Se anche solo una minima parte delle accuse rivolte contro le truppe americane in Afghanistan fosse vera (ma in questo caso la volontà di scoprire la verità sarebbe nulla), questo fatto getterebbe una luce sinistra sul modo in cui in Afghanistan viene «difesa la civiltà», tanto più se qualche membro di quella banda di saccheggiatori imbarbarita, mossa solo da odio e desiderio di vendetta, che è la cosiddetta Alleanza del nord, prova orrore di fronte alle malefatte della soldatesca americana. La «civiltà» capitalistica ha sempre superato qualsiasi «selvaggio» in crudeltà e dunque perché dovrebbe dimostrare un contegno moderato proprio nel momento della sua decadenza globale?
Nel solco del comportamento anomico si colloca anche il trattamento dei soldati talebani e di Al Qaeda, che a centinaia, dopo la loro cattura, sono stati internati dagli USA nella base aerea extraterritoriale di Guantanamo a Cuba per l’«interrogatorio». I prigionieri, già frastornati a causa del viaggio, vengono trattati con modalità che sfidano qualsiasi descrizione: «Non appena l’aeroplano atterra, i prigionieri vengono fatti passare attraverso un portellone di carico. Indossano uniformi e berretti rosso-arancio fluorescenti, affinché ogni loro movimento sia ben visibile. Hanno i polsi ammanettati, i piedi legati con catene. I volti sono coperti da grossi occhiali da sole, incollati con un nastro di colore scuro. Le orecchie sono coperte con dei paraorecchi simili a quelli del personale di terra degli aeroporti. Come se non bastasse portano anche dei guanti. Di conseguenza sono praticamente ciechi, sordi e incapaci di tatto. Il campo assomiglia a una specie di cantiere. Le gabbie in cui vengono ospitati i prigionieri hanno pavimenti di cemento. Misurano 2,40 metri per 1,80. I tetti sono fatti di lamiera. Le “pareti” consistono di pali di ferro e di reti metalliche» (Schwelien 2002).
Le proteste rivolte da Amnesty International, da altre organizzazioni statunitensi per i diritti umani, nonché dai deputati della Camera bassa britannica, contro le condizioni carcerarie cui sono sottoposti i prigionieri, costretti, anche dopo il trasporto aereo, a restare a capo coperto e in catene, inginocchiati di fronte ai loro guardiani, sono state tutte respinte. Ma ad evidenziare la condizione anomica è soprattutto lo status giuridico dei prigionieri: non ne possiedono più uno. Da una parte il loro status non è quello dei criminali, che è possibile processare di fronte al tribunale ordinario di uno Stato. Essi non si trovano in Afghanistan, anche a prescindere dal fatto che là non esiste più un sistema giuridico funzionante; inoltre i combattenti di Al Qaeda non fanno più parte di uno Stato. Come combattenti dall’Afghanistan non possono neppure essere giudicati da un tribunale americano. Dall’altra il governo americano ha già rifiutato di riconoscerli come prigionieri di guerra, evitando così di concedergli le garanzie della Convenzione di Ginevra.
Nella «guerra contro il terrore», la cui durata viene stimata in anni o decenni, lo Stato dell’ultima potenza mondiale precipita anche sotto questo riguardo in una condizione pregiuridica. Proprio come nel caso dei profughi illegali nella terra di nessuno delle zone di custodia degli aeroporti e delle polizie di frontiera, che in quanto non-persone giuridiche sono oggetto di una mera procedura amministrativa, senza la garanzia di uno status giuridico autonomo, questo non-status viene applicato anche ai prigionieri della guerra contro il terrore e in maniera ancora più drastica. Essi scompaiono nei campi militari, dove possono subire atrocità e torture incontrollate. Oppure vengono giudicati al di fuori di qualsiasi fondamento giuridico dai tribunali militari. Si tratta di una giustizia vendicativa allo stato puro e fuori controllo, che non è già più giustizia. Anche su questo livello il mondo capitalistico ufficiale sta muovendo i suoi passi verso lo pseudo-arcaismo dei signori della guerra e dei fondamentalisti religiosi; con la benevole approvazione di un giurista liberale tedesco, assurto ormai a teologo dell’anomia democratica.
Nei protettorati NATO dell’ex-Jugoslavia, dove nel frattempo si punta a realizzare, con il filantropico aiuto della violenza anomica della democrazia globale, le «istituzioni dello Stato di diritto», queste ultime si sgretolano sotto la pressione della «battaglia contro il terrore» ancor prima di essere entrate pienamente in funzione: «In Bosnia deve levarsi la voce del diritto – questo il messaggio dell’Occidente. Adesso la voce del diritto si è levata. Venerdì scorso un tribunale aveva liberato sei arabi, sospettati di avere collaborato con Al Qaeda. Non c’erano prove sufficienti per trattenere i sei che si trovavano in prigione ormai da ottobre. Le autorità statunitensi sostenevano di avere le prove ma non volevano trasmetterle al tribunale di Sarajevo. Di conseguenza i giudici hanno fatto l’unica cosa possibile: hanno rilasciato i sei arabi. Poche ore più tardi però i sospetti erano già tornati dietro le sbarre. Erano stati fermati dai soldati americani e spediti probabilmente a Guantanamo. In centinaia hanno protestato a Sarajevo contro questa procedura. Anche la suprema autorità giuridica del paese, la Camera dei diritti umani, ha fatto sentire la sua voce. Tutto inutile. Le autorità bosniache hanno chiuso tutti e due gli occhi di fronte a questa prassi discutibile. Posti di fronte alla scelta tra la forza e il diritto, hanno optato per la forza» (Ladurner 2002). E del resto non restava loro altro da fare visto che si tratta di autorità di un protettorato dipendente e militarmente occupato.
Nel momento in cui la forma giuridica, il cui fondamento sociale è ormai obsoleto, viene aggredita da un focolaio anomico, le metastasi si diffondono necessariamente in tutti i tessuti giuridici. Il prolungamento del collasso delle relazioni giuridiche dall’esterno verso l’interno assume inizialmente le sembianze della legislazione eccezionale o di emergenza. La società viene avvolta da un’ipotetica rete di sicurezza, che non è affatto una protezione contro il terrore, ma rivela, anche negli ordinari rapporti civili, il nucleo repressivo del diritto, nella forma dell’arbitrio burocratico. Lo shock dell’11 settembre ha scatenato negli USA una dinamica peculiare degli apparati statali e giudiziari, che rende assurdo il positivismo ideologico dello Stato di diritto – e proprio in una patria d’elezione della libertà occidentale.
La corruzione anomica dei rapporti giuridici sembra procedere ad un ritmo addirittura frenetico: «Tutti gli stranieri che, per una ragione o per l’altra, si sono trovati nel cono d’ombra degli attentatori vengono praticamente considerati già quasi come dei fuorilegge: “Se riterrò che il deferimento di questi individui di fronte a un tribunale militare è nell’interesse della sicurezza della nostra grande nazione – ha tuonato Bush – allora questo dovrà essere fatto”. A questo scopo è già prevista l’istituzione di tribunali in cui l’obbligo di fornire prove è limitato e la pena di morte può essere comminata anche solo con una maggioranza dei due terzi. L’impensabile diviene realtà: un sospettato può essere rinchiuso nel braccio della morte dopo un breve processo e senza che l’opinione pubblica possa conoscere le accuse o esaminare le prove […]. Uno scenario teorico? Niente affatto; la giustizia fatta ad immagine delle corti marziali potrebbe presto divenire prassi: secondo il ministro della giustizia Ashcroft, tra i 600 stranieri che risiedono attualmente nelle carceri statunitensi in relazione all’11 settembre ci sono alcuni membri di Al-Qaeda. Nessuno può costringerlo a rendere pubblici i loro nomi – un fatto senza precedenti per lo Stato di diritto statunitense. Per un paio di giorni gli strateghi americani avevano denominato “Giustizia infinita” la guerra anti-terrorismo del presidente Bush. Ma dopo l’11 settembre Bush e Ashcroft, grazie a una produzione incessante di decreti, hanno fatto strame di numerosi e rilevanti fondamenti della legislazione americana. In questa rete a maglie fitte ad essere arrestati sono soprattutto immigrati dal Medio Oriente e dall’Asia centrale, in qualche caso sulla base di accuse davvero inconsistenti. Può restarvi impigliato chiunque abbia il solo torto di essere originario della regione del mondo sbagliata: un benzinaio pakistano di 28 anni, Mohammed Mubeen, è finito nel mirino degli inquirenti solo perché aveva rinnovato la sua patente di guida in Florida 23 minuti prima che uno degli attentatori, Mohammed Atta, entrasse a sua volta nello stesso ufficio della circolazione. Un trentenne egiziano è stato fermato il 24 settembre a St. Louis, dopo aver terminato il suo turno di notte, soltanto perché il suo visto era scaduto. In realtà a prolungargli il soggiorno in prigione hanno pensato la sua origine araba, la sua fede islamica e il suo infausto cognome: Osama. E siccome un mediorientale è pur sempre un mediorientale, nella stessa rete sono caduti perfino una sessantina di giovani israeliani: Jaon Schmuel è stato arrestato con quattro amici solo perché il suo gruppo aveva fotografato con fare sospetto e per un periodo giudicato eccessivo le macerie del World Trade Center. Questo impiego disinvolto della carcerazione come filtro per i sospettati ha generato anche un acceso dibattito criminologico: secondo una dichiarazione dal tenore sarcastico dell’ex-vicecapo dell’FBI, Kenneth Walton, le incarcerazioni di massa sarebbero un derivato della “scuola Perry Mason” – una fase di logoramento iniziale per poi ottenere confessioni da dietro le sbarre […] Questa nuova prassi giuridica dalla dubbia legittimità è stata resa possibile da una macchina da guerra legislativa senza precedenti: il primo passo, ossia la legge che porta programmaticamente il nome di USA Patriot Act, è stata approvata dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato con solo una manciata di voti contrari. Mediante questo provvedimento venne abbassata l’asticella per avere un mandato di perquisizione, per l’autorizzazione, senza troppi preamboli, delle intercettazioni telefoniche e la sorveglianza di Internet, così come per il coordinamento di banche-dati fino a quel momento separate, ad esempio quelle della CIA e dell’FBI. Inoltre la formulazione ambigua di alcune misure esecutive ha reso possibile una considerevole estensione dei poteri delle autorità di polizia. Gli stranieri sospetti possono essere trattenuti in carcere fino a sei mesi, senza che nei loro confronti venga formulata alcuna accusa, nel caso in cui il ministro della giustizia ritenga che ci sia “un pericolo per la sicurezza nazionale”. E il ministro Aschcroft vede questo genere di pericoli dappertutto […]. Persino l’editorialista William Safire, da sempre un convinto sostenitore dell’amministrazione Bush, ha lanciato un grido di allarme: mediante l’installazione di questi tribunali militari, gli USA si sono arrogati “prerogative dittatoriali”. L’esecutivo pretende di essere, simultaneamente, “investigatore, pubblico ministero, giudice, carceriere e boia”» (Hoyng 2001).
Da tempo ormai la liquidazione del diritto, la giustizia segreta e l’arbitrio non si dirigono più solo contro gli «stranieri sospetti» ma anche contro gli stessi cittadini americani. Il ministro della Giustizia Ashcroft, a tempo perso fondamentalista protestante, predicatore e fanatico anti-abortista, la cui visione del mondo (non poi così lontana da quella di Bush) assomiglia come una goccia d’acqua nella sua struttura a quella dei Talebani, si è mobilitato anche contro alcuni milioni di americani di fede musulmana, parallelamente alla plebaglia WASP, che a sua volta agisce patriotticamente dal basso: «La responsabilità di ben cinque omicidi è stata attribuita a patrioti sanguinari che, di solito, sparano dalle loro macchine contro benzinai o cassieri di mini-market “dall’aspetto arabo”. All’indomani di ogni omicidio i distributori di benzina gestiti da egiziani o pakistani espongono grandi bandiere a stelle e strisce. Non solo per una professione di lealtà nei confronti dell’America ma anche per lanciare un appello: “Per favore non sparatemi. Non sono un terrorista”. Le organizzazioni per i diritti civili e le associazioni arabo-americane hanno documentato casi di aggressione, vetri infranti e minacce contro le moschee» (Böhm 2001). Nella «terra del sospetto infinito» gli investigatori dell’FBI fanno visita a cittadini di diverse etnie, ad esempio nel New Jersey, dove i soprusi della plebaglia erano rimasti dentro i limiti: «Sono settimane che gli agenti dell’FBI suonano alla porta di individui dal cognome arabo, pakistano o turco nella zona meridionale della città per chiedere un “colloquio volontario”. Secondo i verbali degli interessati, di norma due agenti interrogano il padrone di casa circa la sua opinione su Osama bin Laden e la “civiltà occidentale”, mentre altri due curiosano in maniera indiscreta nelle stanze, senza neppure togliersi le scarpe» (Böhm 2001).
Dopo l’11 settembre si accumulano le denunce di soprusi da parte degli apparati di sicurezza nei confronti dei cittadini e il Patriot Act ha abbassato la soglia di garanzia per il controllo e la sorveglianza dell’intera popolazione. in questo senso Bush pianifica addirittura l’istituzione di un nuovo terrificante «ministero per la sicurezza interna», che dovrebbe impiegare circa 170.000 effettivi e disporre di un budget annuale di 38 miliardi di dollari.
Naturalmente ciò che è ragionevole per gli USA, lo è ancor più per un paese dalle solide tradizioni poliziesche come la Germania. Sulla scia della campagna anti-terrorismo non è insensato affermare che «tutti i cittadini sono generalmente sospettati»: «Il pacchetto anti-terrorismo del ministro Schilly non si dirige solo contro ipotetici attentatori stranieri ma fa aleggiare l’ombra del sospetto su 82 milioni di tedeschi. Anche cittadini incensurati vengono trattati alla stregua di potenziali criminali […]. Nel pathos della discussione circa le necessità effettive della lotta al terrorismo non ci si arresta più di fronte a nulla: impiego delle forze armate all’interno dei confini nazionali: e perché no? Abolire la linea di separazione tra polizia e garanzie costituzionali: ma è logico! Una banca-dati con le impronte digitali della popolazione: sarebbe fondamentale! Risulta sempre più evidente fino a che punto gli attacchi dell’11 settembre abbiano scosso i pilastri della società liberale» (Knaup et al. 2001).
Lo stile accorato di questo sfogo da parte di un’informazione giornalistica solo relativamente critica si inserisce nel solco dell’elegia democratica: la circostanza oggettiva della degiuridificazione latente, molto difficile da digerire, viene posto in una relazione nostalgica con l’obsolescenza e l’ineluttabile declino del rapporto di potere della modernità (sovranità), invocato come un paradigma ideale, senza riflettere sulle condizioni del suo dissolvimento. Tutto deve restare così, anche se nulla può più restare com’era; e nessuno vuole davvero capirne il perché.
Ma tutte quelle voci che invocano in continuazione i diritti civili, l’ordine sociale liberale (che in realtà è solo un rapporto di forza coagulato) e i valori democratici, immaginandosi così di dare espressione ad un consenso fondamentale nella società (per quanto unicamente sul piano ideologico), non solo si trovano già in minoranza, ma vengono gradualmente costrette al silenzio. Dopo l’11 settembre negli USA, così come in gran parte del mondo occidentale, ha avuto inizio una vera e propria caccia alle streghe secondo il modello del senatore McCarthy, il sinistro «cacciatore di comunisti» dei primi anni della Guerra fredda; una sorta di violenta epurazione, soprattutto nell’ambito dei media, ma anche nella sfera politica e nelle istituzioni educative. Improvvisamente, quasi involontariamente, viene alla luce il carattere totalitario, aggressivo e distruttivo dei «valori occidentali», precisamente perché, in nome del «liberalismo», non solo si diffonde un’atmosfera da crociata, ma ogni analisi anche solo cautamente distaccata viene denunciata come «collaborazione con il nemico».
Chi non si mette «in riga», anche solo per avere formulato una critica innocente, egualmente fondata su quei «valori occidentali» di cui non viene percepita l’autentica natura, rischia seriamente di passare per un eretico e di essere defraudato della propria esistenza sociale come operatore dei media: «Gli esperti dei media stanno registrando con trepidazione una vera e propria inversione negli standard giornalistici che, finora, la stampa americana aveva rispettato con tanto orgoglio. In questo momento i giornalisti devono fare molta attenzione a quello che dicono perché qualsiasi cosa può andare incontro a interpretazioni malevole – ha dichiarato Robert Lichter, presidente del Center for media e Pubblic affairs di Washington. Ci muoviamo su di un terreno molto insidioso. La neutralità nelle scelte lessicali viene tutt’a un tratto interpretata come dissenso recondito dagli obiettivi di guerra americani. Scetticismo uguale irresolutezza. America first, Journalism second – così recita il motto dei fautori del nuovo patriottismo. Adesso ciò che si esige non è certo la capacità di riflessione ma una fiammeggiante professione di fede […] Negli ultimi tempi anche una star del settore come Geraldo Rivera della CNBC sta affrontando il suo lavoro come se fosse una ”missione”. Non potendo appagare a sufficienza il “bisogno di vendetta” dalla sua poltrona su di un canale finanziario, Rivera ha deciso di firmare un nuovo contratto da sei milioni di dollari per fornire le notizie direttamente dall’Afghanistan sul canale Fox News – il che gli ha assicurato un bel po’ di pubblicità e parecchi consensi. Al contrario l’inviata della CNN Christine Amanpour, molto apprezzata anche in Europa per il suo stile misurato, è stata ingiuriosamente apostrofata dal New York Post, uno dei più diffusi quotidiani popolari negli USA, come “prostituta di guerra” […]. In qualche caso basta solo una formulazione azzardata o un’osservazione percepita come inopportuna per passare dal ruolo di cacciatore di notizie a quello di preda […]. Ari Fleischer, portavoce della Casa Bianca, ha ammonito gli americani: state molto attenti a quello che dite (!) » (Fleischhauer 2001).
Ma a manifestarsi qui non è la rottura con il principio freedom and democracy ma l’autodecomposizione del medesimo principio nei suoi elementi originari, cioè logica di violenza e fanatismo ideologico (originariamente protestante). L’ovattata coscienza intellettuale democratica dei quartieri alti non può che provare sgomento di fronte a questa situazione, come dimostra la scrittrice newyorkese Francine Prose: «La rapidità con cui una società da sempre orgogliosa per il suo impegno a favore del pluralismo e del dibattito democratico […] si è trasformata in una civiltà che identifica il dissenso con il tradimento è quasi altrettanto scioccante degli avvenimenti dell’11 settembre. Quei pochi intellettuali, critici sociali ed artisti – come, ad esempio, Susan Sontag e Wallace Shawn – che hanno osato esprimere in pubblico anche solo la minima riserva nei confronti della nostra politica estera sono stati duramente attaccati, non solo dai giornali della destra conservatrice, ma persino dalla stampa moderata» (Prose 2002).
Un certo numero di giornalisti americani «poco attenti a quello che dicevano» sono stati licenziati. Anche in altri paesi fioccano i racconti circa punizioni disciplinari e aggressioni da parte dei filobellicisti, ad esempio in Gran Bretagna, nei confronti dei «deviazionisti» della frazione laburista: «Il deputato laburista Paul Marsden, 33 anni, è stato aggredito da alcuni colleghi del suo stesso gruppo parlamentare nella Camera bassa perché in dissenso con la discussa legge anti-terrorismo del governo Blair […]. Anche se Blair otterrà senza troppi problemi l’approvazione della legge alla Camera bassa prima di Natale, alcuni deputati fedeli alla linea, stando alle dichiarazioni di Marsden, lo hanno pesantemente insultato allo “Strangers’ Bar” della Camera bassa, quindi lo hanno spintonato e preso per il collo» (Der Spiegel 50/2001).
Questo quadretto fugace circa la raffinatezza dello stile britannico, così come i resoconti sulle feroci persecuzioni nei media statunitensi, ci offre solo una panoramica aleatoria del clima di odio e di sospetto scaturito dopo l’11 settembre nelle metropoli democratiche, che sanziona duramente chiunque osi mettere in dubbio un’interpretazione dei fatti dal carattere primitivo e manicheo. Questa pretesa di arrendevolezza preventiva nei confronti delle grida di vendetta del manicheismo democratico è costata molto cara anche ad alcuni insegnanti del sistema scolastico tedesco, colpevoli esclusivamente di avere invocato la consueta liturgia democratica (ancora in voga fino a non molto tempo fa) a base di «composizione dei conflitti», «educazione alla pace» e via dicendo. Sospensioni dal servizio, trasferimenti d’ufficio e richiami disciplinari sono stati registrati in quasi tutti i Länder; il problema è che certi insegnanti non si erano resi sufficientemente conto del fatto che, in questo frangente, qualsiasi critica alla NATO e alla guerra democratica dell’ordine mondiale, nel circo prosaico della commozione mediatica, può essere pericolosa per l’esistenza.
Un esempio su tutti: un insegnante di Siegen, Bernhard Nolz, è stato sospeso dal servizio per avere criticato la politica statunitense nei confronti dell’ONU dopo l’11 settembre: «A Nolz è stata rimproverata la sua mancanza di sensibilità. Anche se in precedenza, su richiesta della municipalità, aveva messo in rete il registro delle condoglianze per le vittime. Il rappresentante degli studenti ha preso le distanze da Nolz. La CDU, nella persona di Paul Breuer, deputato al Bundestag, lo ha attaccato in questi termini: “Non è adeguato al suo ruolo di insegnante”. Breuer ha affermato addirittura che […] ci sarebbe “una spregevole connivenza con i terroristi” […] Il direttore della scuola Walter Karbach avrebbe percepito nelle parole di Nolz “accenti antiamericani di pessimo gusto” e così lo ha sospeso per “disturbo della pace scolastica”. E il presidio governativo locale ha dato l’avvio a un’istruttoria preliminare ai sensi del regolamento disciplinare» (Ver.di Publik 2002).
Naturalmente il reperto empirico della caccia alle streghe necessita di un’interpretazione, che deve includere la struttura complessiva della crisi mondiale e del processo di decomposizione della sovranità. Ogni singolo caso di pressione amministrativa, censura, diffamazione e denuncia penetra solo casualmente e in minima parte nella sfera pubblica, la cui condizione mercificata pregiudica di per sé la possibilità di discutere seriamente i problemi sociali e che inoltre inizia a caricarsi sempre più con una primordiale propaganda fomentatrice, già post-politica.
La qualità morale e civilizzatrice della tendenza affiorata dopo l’11 settembre risalta particolarmente da fatti come questo: a proposito del «trattamento» dell’inafferrabile e impenetrabile terrorismo, nello stile della propagandistica riflessione democratica, con una franchezza che non suscita ormai più scandalo alcuno, vengono discussi «temi», il cui carattere inumano, barbarico avrebbe sollevato fino a poco tempo fa solo spavento.
A fare da battistrada ci ha pensato il magazine militare Soldier of Fortune, diretto dal colonnello Robert K. Brown, un veterano del Vietnam: «Alcuni dei problemi sollevati da Soldier of Fortune sono già oggetto di discussione da parte dei media. Ad esempio Brown ha intervistato un ex-generale francese, responsabile di torture in Algeria negli anni Cinquanta, e gli ha posto il seguente interrogativo: “La tortura può ostacolare il terrorismo?”. Secondo il New York Times la liceità della tortura è stata dibattuta anche in un editoriale del Wall Street Journal, in un articolo di Newsweek, e perfino da due importanti network come Fox News Channel e CNN, cagionando raccapriccio nelle organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International» (Wirtschaftswoche 46/2001). «È giunto il momento di riflettere sulla tortura»: questo il titolo dell’articolo di Newsweek (Fleischbauer 2001).
La tabuizzazione della critica alla vera sostanza dei «valori occidentali», alla criminalizzazione delle posizioni scettiche, anche solo in un senso sterilmente immanente, è in relazione con il dibattito democratico sulla legittimità della tortura. In Israele gli estremisti di destra del Likud e i fanatici ultra-ortodossi ci erano arrivati già da tempo, suscitando certamente l’orrore delle forze laiche, liberali e di sinistra.
Si tratta proprio di un’omologazione, sia sul piano morale che su quello pratico, nei confronti di quella barbarie che però, d’altro canto, viene additata come il nuovo nemico globale. È questa la migliore testimonianza del fatto che questo nemico è carne dalla carne della democrazia stessa. La canaglia razzista così come i falchi mediatici e politici delle guerre dell’ordine mondiale, delle crociate, della liquidazione del diritto e della privatizzazione della violenza non sono un paradosso ideologico; essi invece decompongono la democrazia della prosperità del dopoguerra nei suoi reali elementi costitutivi: portano alla luce il meccanismo della democrazia, proprio mentre lo distruggono, e lo distruggono proprio nello sforzo militante di mantenerlo in vita.
Note:
1. Robert Kurz, Weltordnungskrieg, Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung, Horlemann Verlag, Bad Honnef 2003.

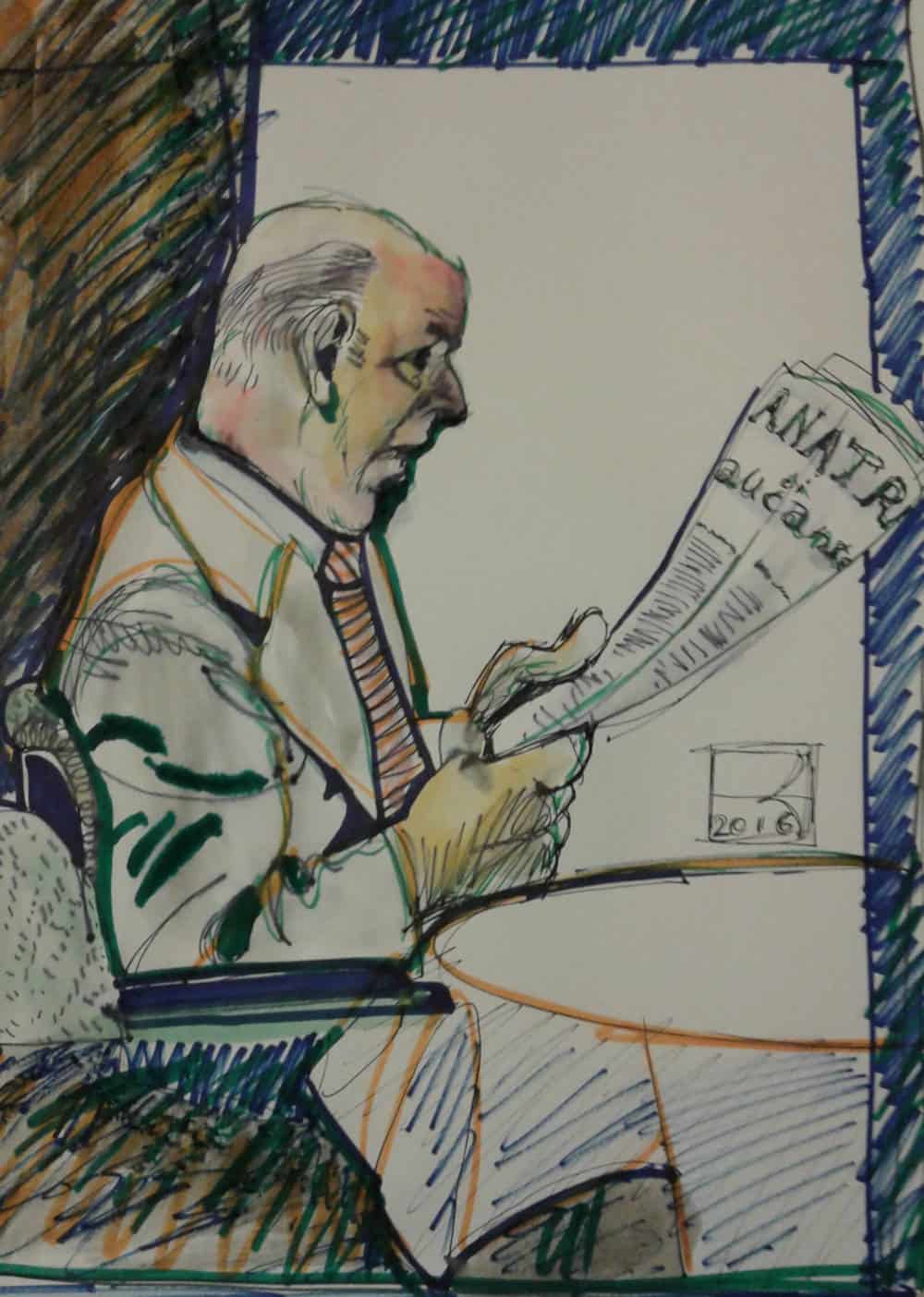

Un commento