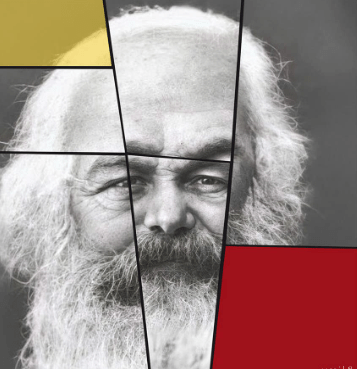Afshin Kaveh intervista Roberto Fineschi, attento studioso di Marx, proseguendo con la serie di interviste a personaggi non direttamente legati alla Wertkritik ma che in qualche modo si pongono, o possono farlo, in un rapporto costruttivo con questa. In precedenza era stato intervistato Wolf Bukowski.
***
Afshin Kaveh: Potrebbe tracciare una breve storia della seconda Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA 2) – annesse le differenze, per esempio con la MEW, Marx-Engels-Werke – e quali sono le prospettive aperte sinora dall’operazione di questa nuova edizione critica delle opere complete di Marx ed Engels?
Roberto Fineschi: L’edizione è detta seconda perché ci fu un primo tentativo di realizzare una Gesamtausgabe tra gli anni Venti e Trenta del Novecento a opera prima di Rjazanov e poi di Adoratsky. Questo secondo tentativo è tuttavia un progetto completamente nuovo, basato su criteri filologici e struttura diversi. Inizialmente a cura degli Istituti per il Marxismo-Leninismo rispettivamente di Mosca e Berlino est, con la fine della guerra fredda è adesso curata dalla Fondazione Internazionale Marx-Engels, con sede ad Amsterdam e principale centro operativo presso l’Accademia delle Scienze di Berlino e del Brandeburgo. A differenze della prima che prevedeva solo tre sezioni, la seconda ne presenta quattro: I) le opere e gli abbozzi (escluso Il capitale), II) Il capitale e i lavori preparatori (a partire dal 1857), III) il carteggio, IV) gli estratti/annotazioni. L’ultima sezione è una novità assoluta. Un’edizione critica si differenzia da una normale edizione di opere perché presenta tutti i testi editi e inediti, a tutti i livelli di lavorazione, nella loro forma/lingua originale. Una tale precisione e complessità è in genere impossibile in un’edizione di Opere che adotta criteri che mirano a una maggiore leggibilità e schematizzazione. Marx ha pubblicato in vita molto poco rispetto a quanto ha scritto; soprattutto alcune delle sue opere fondamentali sono state edite dopo la sua morte in maniera non sempre adeguata: per es. i Manoscritti economico-filosofici, L’ideologia tedesca, il secondo e il terzo libro de Il capitale li abbiamo conosciuti in forme pesantemente editate. L’edizione storico-critica mette a disposizione dei lettori e degli studiosi sia i testi editati (oramai diventati essi stessi dei classici, in particolare i libri de Il capitale), ma anche tutti i manoscritti preparatori in forma filologica, ovvero per quanto possibile neutrale. Si può dunque procedere a un confronto tra quanto fatto da Marx in persona e il lavoro dei suoi editori. Ciò, si badi bene, non significa che i suoi editori siano dei “traditori” o chissà cosa, ma semplicemente che il loro lavoro nel bene e nel male ha inciso sull’opera. Ora è finalmente possibile tornare all’originale e vedere se esso offre possibilità che invece sembravano precluse dalle versioni date alle stampe.
AK: Col suo libro Marx e Hegel appena uscito in una seconda edizione, potrebbe esporci nel dettaglio il rapporto che l’agitatore di Treviri ha avuto col maestro di Stoccarda? Perché non ha mai avuto senso la monca lettura althusseriana di una “rottura epistemologica” nella vita e nell’opera teorica di Marx? Intendo tra un Marx giovanile hegeliano e uno maturo e scienziato.
RF: Il discorso è ovviamente molto complesso, cercherò di schematizzare per quanto possibile le tesi fondamentali. Storicamente, in gran parte delle interpretazioni marxiste, non si è usciti dall’ottica di Marx, ovvero non è venuto in mente di vedere se quanto egli diceva di Hegel era sostenibile o meno. Nel libro cerco di mostrare come la ricezione di Marx sia stata fortemente influenzata dal contesto dei giovani hegeliani e come la maggior parte delle critiche che essi muovevano a Hegel – soprattutto che la sua sarebbe una teoria dell’Autocoscienza e che il nesso fondamentale sarebbe il rapporto tra idealismo e materialismo – non è sostenibile. La teoria hegeliana non è riducibile all’Autocoscienza e il suo è sostanzialmente un realismo e non certo uno spiritualismo per cui il pensiero crea fattualmente la realtà, così come lo interpretava lo stesso Marx in passi noti. Nell’interpretazione di Marx la teoria di Hegel perde in sostanza molto del suo lato “reale”, tanto nell’analisi dei processi storici che producono la modernità, quanto nella ricostruzione delle strutture sociali (già per larghi tratti capitalistiche) che essa propone; la realtà si riduce al risultato di un processo conoscitivo del pensiero, al prodotto del soggetto pensante, per quanto collettivo. Addirittura questo processo del pensiero arriverebbe a creare la realtà stessa non solo come vita sociale ma addirittura nella sua stessa materialità. Superati questi equivoci cerco di mostrare come, al di là della propria comprensione, Marx utilizzi a tutti gli effetti, per sua stessa ammissione, il metodo dialettico e, nel far questo, come sia più coerente con gli assunti metodologici hegeliani di quanto non credesse egli stesso. Offro una rigorosa analisi categoriale in cui cerco di mostrare molto nel dettaglio le tesi che qui ho brevemente riassunto. Il problema con Althusser nasce dalla sua identificazione/appiattimento per cui Hegel/dialettica/alienazione/filosofia sono la stessa cosa. Per eliminare l’alienazione umanistica egli si vede quindi costretto a far fuori anche tutto il resto. Credo che questa semplificazione non sia oggi più sostenibile. Marx sicuramente precisa i termini del concetto di alienazione nell’opera matura, ma questo non significa che rinunci alla dialettica hegeliana. Anche perché in Hegel, come cerco di dimostrare nel libro, il concetto di alienazione non ha affatto la centralità che gli attribuiva Marx e quindi rinunciare a quella categoria espressa in quei termini, non significa affatto far fuori Hegel, semmai far fuori una cattiva interpretazione della sua filosofia. La nuova edizione approfondisce poi il tema della dialettica e del rapporto tra Marx e Hegel anche in altri autori come Lenin, negli interpreti della Filosofia della prassi, ecc.
AK: Perché ritiene filologicamente e contenutisticamente scorretto parlare di una teoria del “valore-lavoro” in Marx? Potrebbe esporre le differenze con quella che lei, mi pare, ha definito una teoria di “merce e denaro” così come titola in apertura la prima sezione de Il capitale?
RF: Ho affrontato in dettaglio questi temi in un altro mio testo, La logica del capitale. È scorretto per il semplice motivo che, in quei termini, la categoria nel testo semplicemente non c’è, è semmai un’invenzione di Böhm-Bawerk. Marx parla sempre, senza ombra di smentita testuale, di merce e denaro. Sostanza di valore, grandezza di valore, forma di valore e valore d’uso sono determinazioni concettuali della merce e non del prodotto; solo in determinate circostanze storiche il dispendio di forza-lavoro e la sua misura attraverso il tempo, che come tali ci sono sempre stati e sempre ci saranno, diventano categorie economiche, vale a dire nella società in cui il prodotto assume la forma di merce. E in questa società il carattere sociale del dispendio individuale/privato si riconosce solo nella mediazione dello scambio (forma di valore). Credere che il valore sia intrinseco al prodotto è esattamente il feticismo della merce. La tradizionale teoria del valore-lavoro riduce tutto a sostanza e grandezza di valore, per di più talvolta interpretate come determinazioni non della merce, ma del prodotto e del lavoro in generale, procedendo così a un appiattimento della forma sociale capitalistica sulla natura stessa; così il mero calcolo delle ore dà tanto il valore quanto il prezzo delle merci, ciò che Marx dice essere impossibile in una società mercantile. L’interpretazione tradizionale è in sostanza una delle tante varianti del feticismo della merce che naturalizza ciò che invece è socialmente e storicamente determinato. Questa interpretazione nasce dalla mancata comprensione della clausola fondamentale del livello di astrazione del primo libro, vale a dire la coincidenza di produzione e consumo, di domanda e di offerta: data questa premessa il dispendio di lavoro privato – che come tale non necessariamente corrisponde a quello socialmente necessario – si può già considerare socialmente necessario perché si garantisce a priori che ciò che è stato prodotto sarà venduto. Questo però è possibile solo data questa clausola che viene fatta cadere nel terzo libro, in cui la forma di valore diventa decisiva e dà vita a una nuova categoria, il valore di mercato (dove si considera la questione della realizzazione, e quindi del riconoscimento sociale, di ciò che è stato prodotto privatamente), che nell’interpretazione tradizionale non viene neanche menzionato. Sul fatto che la forma di valore sia ciò cui Marx tiene di più non c’è filologicamente dubbio alcuno, trattandosi della parte della sua teoria che ha rielaborato più volte; nel dibattito tradizionale viene semplicemente omessa. La teoria del valore-lavoro è una lettura possibile de Il capitale, ma al costo di perdere parti sostanziali della teoria e quindi di snaturarne il senso profondo. La lettura che propongo nel libro menzionato invece cerca, proprio a partire da questa riformulazione, di impostare non tanto le soluzioni ma i problemi stessi in una maniera diversa che ritengo filologicamente molto più solida.
AK: Ha mai avuto modo di confrontarsi con l’opera degli autori che ruotano attorno alla corrente internazionale della “Wertkritik” (Critica del valore)? Potrebbero esserci punti di contatto tra la sua teoria del “capitalismo crepuscolare” e il “collasso della modernizzazione” di Robert Kurz? Secondo quest’ultimo il modo di produzione capitalistico vive un limite interno irreversibile dovuto alle contraddizioni del suo stesso funzionamento logico: da una parte esso dipende dalla “valorizzazione” come movimento tautologico la cui “sostanza” è il lavoro mentre dall’altra, nella rincorsa all’automazione per incrementare i processi produttivi, avviene l’esclusione e l’espulsione tecnica dello stesso lavoro vivo, la cui diminuzione comporta non la caduta tendenziale del saggio medio di profitto ma, bensì, la caduta della massa del “plusvalore sociale”, una stagnazione della “valorizzazione del valore” compensata dalla moltiplicazione autoreferenziale del “credito” e del “capitale fittizio” – la cui realizzazione è poi incerta e sempre più difficoltosa – e la creazione crescente di masse di “superflui”, con conseguente imbarbarimento sociale tra razzismo, smantellamento dei servizi d’assistenza, legittimazione delle estreme destre e ritorno alla guerra. Può esporre la sua teoria del “capitalismo crepuscolare”? Secondo lei quanto è importante in Marx la teoria della “crisi”?
RF: Non ho una conoscenza sufficiente di questa corrente per esprimere un giudizio ponderato. Alcuni punti di contatto ci sono sicuramente. Per es. la mia tesi è che i processi obiettivi del capitalismo maturo, “crepuscolare”, tendano all’automazione estrema, all’estromissione in massa della forza-lavoro (asintoticamente all’eliminazione del lavoro vivo, cosa però impossibile nell’ottica capitalistica, questo genera la contraddizione fondamentale), quindi alla crisi sostanziale del processo di valorizzazione per la caduta della massa del plusvalore, non solo del suo saggio. Questo porta a un capitalismo di rapina che non dà valorizzazione in senso tecnico, ma semplice espropriazione in varie forme di cui quelle finanziarie sono le principali ma non le uniche: si può tornare alla vecchia violenza diretta. Ciò porta anche alla crisi delle forme ideologiche fondamentali della società e cultura borghese, come l’universalità del concetto di persona che diventa impossibile praticare sia in Occidente per l’estromissione crescente della forza-lavoro (senza stipendio non si può praticare concretamente la propria astratta personalità), sia nei mondi periferici in cui il capitalismo perde qualsiasi capacità di espansione egemonica proprio per la crisi del processo di valorizzazione. In questo contesto la neo-schiavitù interna e la violenza diretta esterna (guerra) divengono due facce della stessa medaglia.
Da quanto leggo superficialmente (ma cercherò di approfondire la questione) credo ci possano essere dei punti di contatto nell’analisi. Non sono sicuro che questi punti di contatto si estendano alle vie di uscita; non ho ancora ben capito come dall’astrazione capitalistica si riesca a passare a un nuovo mondo “concreto”, questo però è sicuramente un mio difetto di conoscenza. Da parte mia non mi sento di dire che tutte le astrazioni che il modo di produzione capitalistico produce siano negative. Bisogna secondo me distinguere la sua natura contraddittoria e cogliere a cosa, da un punto di vista epocale, non si può rinunciare anche in una possibile società futura non basata sullo sfruttamento. In questo campo tuttavia ho personalmente più domande che risposte, quindi credo che un dialogo costruttivo tra chi si pone questo tipo di problemi sia un passaggio necessario.
Per quanto riguarda la teoria della crisi, credo si possa sostenere che essa è decisiva in Marx e che si sviluppa in filigrana attraverso tutti i livelli di astrazione delle teoria per le sue condizioni di pensabilità (merce e scambio, compera e vendita, denaro come mezzo di pagamento, schemi della riproduzione generale, determinazione del valore di mercato, abbozzo di teoria del ciclo nella caduta tendenziale, accumulazione reale e fittizia nell’ultima sezione sul credito, ecc.). Tuttavia è rimasta allo stato di abbozzo proprio perché Marx non ha fatto in tempo a scrivere i libri sul commercio estero, sul mercato mondiale, dove sicuramente avrebbe avuto lo spazio adeguato. Esistono però secondo me tutte le premesse per svilupparla adeguatamente.
AK: Sicuramente, se esiste un punto su cui non credo possa avvenire un contatto tra lei e la Wertkritik, quello è il campo del “lavoro”. Infatti la “Critica del valore” si presenta anche come una spietata critica del lavoro, non solo nel suo lato astratto ma bensì in generale in quanto categoria meramente capitalistica (si veda il Manifesto contro il lavoro recentemente riedito in una nuova edizione critica). Qual è il suo punto di vista sulla categoria “lavoro” e sul “lavoro” come sintesi sociale?
RF: Direi di primo acchito che parlando di “lavoro” genericamente si rischia di cadere tra le braccia dell’ideologia capitalistica e nel feticcio della formula trinaria: capitale, rendita, lavoro.
In realtà Marx ha, a mio modo di vedere, una stratificata concezione che la mera parola “lavoro” semplicemente rischia di mistificare. Da una parte c’è il processo lavorativo, di cui il lavoro è uno degli elementi; tale processo è trans-storico, indica gli elementi generalmente presenti in ogni processo (attività, mezzo, oggetto, finalità e prodotto come risultato) e che come tale non ci dà alcuna forma storica determinata. Poi esistono le forme storicamente determinate in cui esso si realizza che variano molto da epoca a epoca a seconde della specificità di combinazione e operatività di quegli elementi e che quindi vanno analizzate nel dettaglio. Nel modo di produzione capitalistico e nella produzione di merci bisogna distinguere il lavoro astratto che produce merci (che non necessariamente è parcellizzato e reso unilaterale, può essere super complesso ma resta comunque astratto in quanto viene considerato solo come produttore di valore) e il lavoro astratto nel senso che diventa sempre più unilaterale e parcellizzato nella produzione capitalistica tecnologicamente avanzata (ma Marx questo in verità non lo chiama lavoro astratto). Confondere i tre piani è secondo me un gran pasticcio interpretativo che già è stato fatto tante volte. Onestamente non sono in grado di valutare in che misura nei testi indicati si proceda a queste distinzioni; questa sarebbe tuttavia la prima cosa che andrei a verificare.
AK: Dato che ha precedentemente citato le astrazioni del capitalismo volevo chiederle, a proposito del modo di produzione capitalistico come sintesi sociale che fa astrazione dal contenuto materiale del mondo su cui si crea (es. non mi interessa produrre uva perché è nutriente ma per la sua capacità di vendersi su mercati anonimi e convertirsi in più denaro, infatti se invenduta, alla faccia della sua utilità nutriente data materialmente dal suo corpo organico, finirà comunque in discarica), cosa ne pensa di quelle letture critiche che guardano alle cause e concause dell’irreversibile collasso ecologico come diretta conseguenza del capitalismo? Penso al libro Cemento di Anselm Jappe (rimanendo al contesto della “Critica del valore”) o alle attuali correnti ruotanti attorno al mondo dell’ecologia marxista nelle correnti, tra le tante, di Foster e Moore. O al nuovo “fenomeno” Saito. Che nesso esiste tra capitalismo e degrado/decadimento ambientale?
RF: Anche qui non posso che denunciare la mia ignoranza e le mie insufficienze e quindi non posso esprimere un giudizio nel merito, mi limito a qualche osservazione di carattere generalissimo. Direi che un’ecologia che non configuri una ristrutturazione sistemica del modo di produzione capitalistico, ovvero che non prospetti una via di uscita strutturale ma che si limiti a critiche di alcuni aspetti di esso, rischia di cadere nell’utopismo. Il modo di produzione capitalistico sta in piedi sul processo di valorizzazione; se questa è la sua condizione basica di esistenza, tutto il resto diventa derivato. L’irreversibile disastro ecologico, se valorizza il capitale, è un’opzione sul tavolo; l’osservazione che ciò porterebbe anche alla distruzione del capitale è poco efficace, perché senza valorizzarsi il capitale si distrugge lo stesso; non è dunque un deterrente sufficiente. L’uscita dalla logica strutturale della valorizzazione è la sola possibilità di un’ecologia praticabile; dunque l’ecologia ha bisogno di un modello alternativo di società e sviluppo che però non può essere una generica decrescita o un’astratta riduzione di produzione e consumi, perché questo nel capitalismo non è possibile. Bisogna affrontare i gangli della struttura del capitale. Non dico che questa sia la posizione della Wertkritik, beninteso, sono considerazioni a margine di principio.
Fatte queste precisazioni, che la critica del capitale vada a collegarsi con il tema ecologico lo vedo come un aspetto positivo perché va a intercettare nuove esigenze e prospettive comunque di critica al capitale. Questo spiega il “fenomeno” Saito che saluto con piacere, pur avendo qualche remora, a mio modo di vedere, sull’uso disinvolto dei materiali tardi, al quale viene data un’importanza eccessiva (sono pur sempre note ed estratti, il principio filologico della gerarchia delle fonti va salvaguardato).
AK: Concluderei con una notizia che merita decisamente diffusione. Di recente ha curato una nuova traduzione del primo libro de Il capitale di Marx edito da Einaudi. Quali prospettive apre questa nuova edizione? Può parlarcene un po’ più nel dettaglio?
RF: L’intento primo è stato dare al lettore italiano un accesso ai risultati filologici della nuova edizione storico-critica che propone una grande quantità di materiali prima inaccessibile e consente una più precisa comprensione del testo. La nuova edizione italiana presenta al lettore italiano il primo libro con tutte le numerose varianti, migliorie, trasformazioni che esso ha subìto nel corso delle diverse redazioni curate personalmente da Marx ed Engels (quattro edizioni tedesche e una francese). Si può in sostanza ripercorrere la genesi delle categorie nella loro stratificazione; questo consente di capire a pieno il loro significato e dunque di riconsiderare in questa luce parte del dibattito storico ossificato su posizioni che, a mio parere, hanno fondamenta filologiche fragili (il valore-lavoro ne è l’esempio per antonomasia).
L’altro aspetto è la traduzione. Si è cercato di rendere con maggiore precisione di quanto non fosse stato fatto in passato il lessico filosofico di Marx e la distinzione di alcune categorie che erano andate “lost in translation”. In particolare si è cercato di sottolineare la delicata distinzione tra lavoratore e operaio che in tedesco sfuma, perché il termine “Arbeiter” significa contemporaneamente tutte e due le cose, ma che nelle lingue neolatine diventa una questione dirimente, perché in certi casi tradurre con operaio limita fortemente l’impianto teorico marxiano e può portare a errori sia interpretativi che pratici. Tradurre per esempio “Arbeiter” con operaio quando ci si riferisce al calcolo del saggio e della massa del plusvalore fa pensare che sia solo l’operaio a poterlo produrre, cosa non vera. Oppure quando ci si riferisce alla determinazione delle leggi generali della disoccupazione o dell’opposizione del portatore della forza-lavoro al capitale, ecc. Nella traduzione di queste determinazioni generali, utilizzare “operaio” mozza letteralmente le capacità interpretative della teoria marxiana del capitale.
Altre questioni lost in translation: nelle vecchie traduzioni, per esempio, scompare la cruciale distinzione tra darstellen (l’esposizione scientifica concettuale) e vorstellen (la rappresentazione dello stesso processo da parte degli attori alla superficie della società), entrambi tradotti con “rappresentare”. Oppure Sache, la “cosa”, quella che si cosifica, reifica, soprattutto nelle versioni aggettivali o avverbiali diventava “materiale” o altri termini, facendo così perdere il riferimento diretto al feticismo.