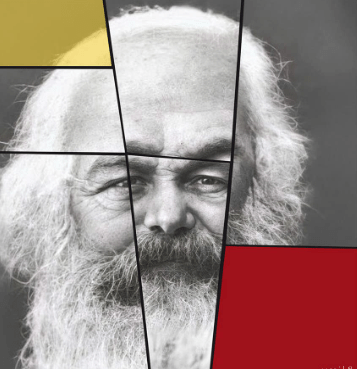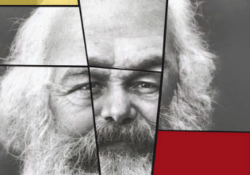La scomparsa della circolazione e la logica del capitale
di Robert Kurz e Samuele Cerea
La sfera della circolazione come illusione capitalistica. L’unica legge, per il capitale, è il proprio accrescimento infinito, costi quel che costi Continua a leggere