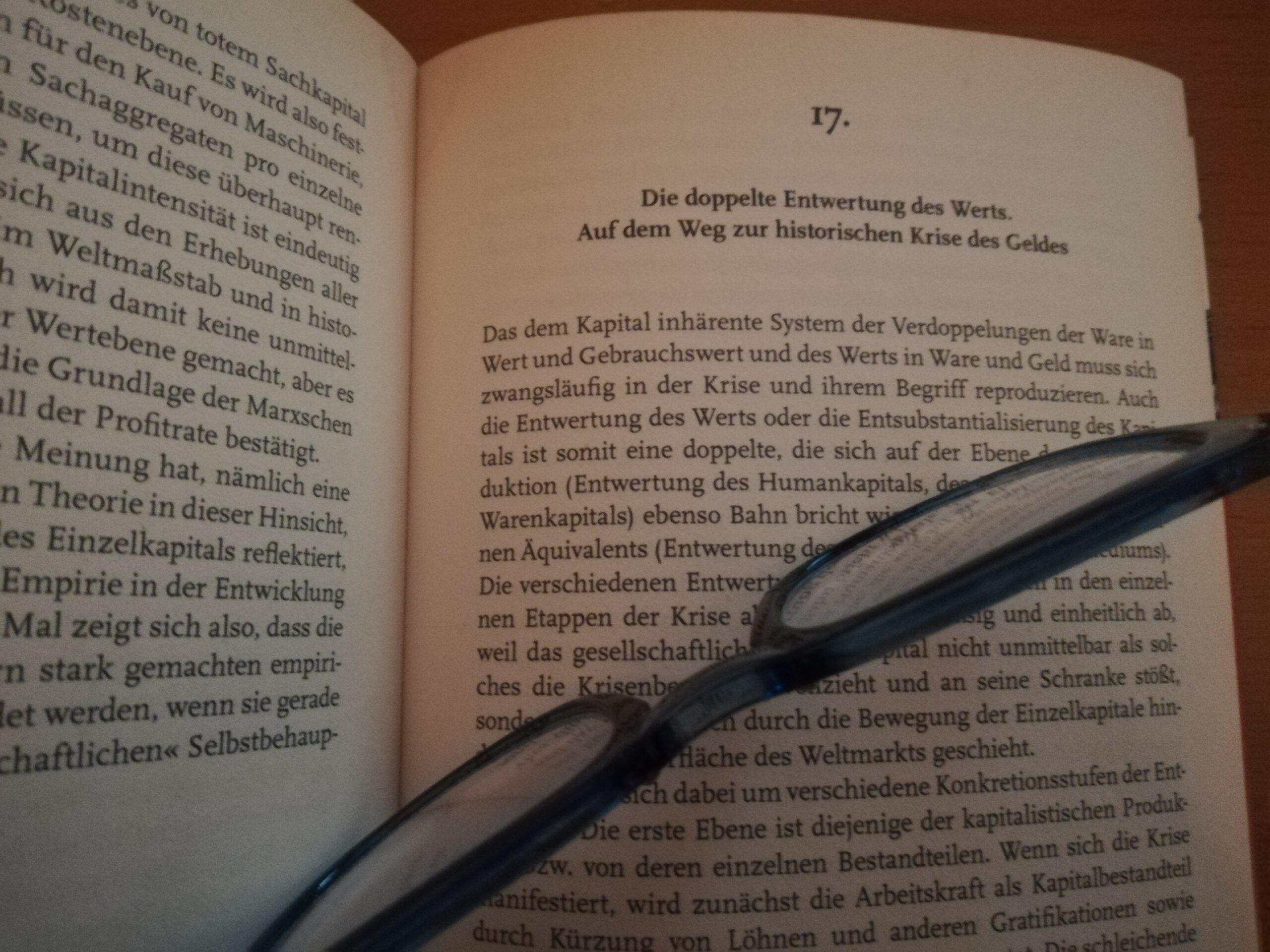Pubblichiamo la traduzione di Samuele Cerea del cap.XVII di Geld ohne Wert, ultimo libro pubblicato in vita da Robert Kurz, preceduta da una breve introduzione del traduttore.
—
L’ultimo saggio ultimato da Robert Kurz, Geld ohne Wert, rappresenta un tentativo ambizioso di rinnovare la critica dell’economia politica di Marx in una prospettiva eterodossa di superamento rispetto all’originaria esposizione de Il Capitale. Il capitolo XVII del testo si focalizza sulla crisi del denaro come aspetto specifico della crisi generale della valorizzazione capitalistica.
A cosa serve il denaro? Come è noto, per la teoria economica si tratta di uno strumento indispensabile in una società che si fonda su di un regime generalizzato di transazioni economiche. Secondo i manuali di economia il denaro funziona da mezzo di pagamento, unità di conto e misura e riserva del valore. In cosa consiste però il valore del denaro? Cosa si intende dire quando si afferma che esso ha un valore? Rappresenta effettivamente il valore in senso sostanziale, oggettivato? Oppure il valore del denaro si esaurisce semplicemente nella sua funzione di mediazione tra diversi beni nella sfera del mercato, soggetta alla legge della domanda e dell’offerta, sotto la garanzia dello Stato?
Nell’argomentazione di Kurz la mediazione di un denaro simbolico, privo di valore, può avere senso solo in una società fatta di produttori indipendenti che si limitano a scambiarsi vicendevolmente beni materiali in una nicchia di mercato. Ma con l’avvento della società capitalistica questa relazione si inverte: sono i beni materiali ad essere un termine medio in seno ad un movimento che mira ad incrementare una certa quantità di denaro iniziale. In questo senso il denaro diviene qui l’alfa e l’omega del processo produttivo (di valore). Di conseguenza esso non è più un semplice mediatore ma si converte nello scopo dell’intero processo sociale. Come afferma Kurz ne Il Capitale-mondo “l’economicizzazione del mondo equivale alla sostanzializzazione del denaro”. E la sostanza di valore del denaro consiste nel lavoro astratto assorbito nel corso del processo produttivo. Ma con la scientifizzazione della produzione questa sostanza di lavoro viene irrimediabilmente erosa avviando la devalorizzazione di ogni elemento del capitale, la forza-lavoro, le merci e, naturalmente, il denaro.
Fu dapprima lo Stato, non il capitale privato, durante l’epoca delle guerre mondiali, con la sua tradizionale fame di risorse monetarie per finanziare gli apparati militari, ad innescare la crisi del denaro. A differenza che nel passato però gli Stati non potevano permettersi di dissanguare troppo la base capitalistica della propria sussistenza mediante le imposte, né violare le regole di un sistema finanziario ormai sviluppato, rifiutandosi di onorare i debiti contratti. Essi dovettero mettere in atto una politica monetaria nuova e pericolosa basata sulla produzione di pseudo-denaro da parte delle rispettive banche centrali cui seguì il fenomeno del tutto nuovo di una devalorizzazione interna del denaro, sotto forma di inflazione e iperinflazione.
Col passare del tempo a questo problema si aggiunse l’espansione continua del credito anche presso i capitali privati, legata al massiccio aumento dei costi preliminari del processo produttivo, e la costituzione di catene creditizie che equivalevano ad una ipoteca su una quantità gigantesca di valore futuro il quale, da una parte, consentiva al sistema di restare in moto ma, dall’altra, aveva effetti potenzialmente destabilizzanti. Non fu più possibile alcun ritorno allo standard aureo in quanto il legame con l’oro avrebbe ostacolato il necessario sviluppo illimitato del sistema creditizio. Finalmente, all’inizio degli anni Settanta, venne disattivata anche l’ultima valvola di sicurezza, ossia l’ancoraggio, per quanto limitato, del sistema monetario al dollaro come valuta di riferimento globale.
Sul piano teorico questo processo venne interpretato ideologicamente in maniera favorevole come un’evoluzione peculiare del denaro verso la progressiva emancipazione dal suo vincolo con la base metallica, ritenuto un inutile anacronismo. Fu il trionfo di una versione estremista del cosiddetto nominalismo o “cartalismo” (di cui la “Moderna teoria monetaria” rappresenta l’ultima propaggine). E il processo di inflazione secolare venne giudicato, almeno all’inizio, come un fenomeno graduale e controllabile. Nel corso degli anni Settanta, con la fine della fase di accumulazione dell’epoca fordista e l’aumento della disoccupazione, lo iato tra plusvalore prodotto e anticipato fittiziamente si fece sempre più ampio. Fu l’intervento keynesiano dello Stato a scatenare ulteriormente il potenziale inflazionistico in presenza di una crescita asfittica (l’epoca della stagflazione) senza venire a capo della situazione. La reazione fu il recupero del vecchio programma neoliberale che fraintese il problema incolpando l’interventismo statale che invece stava solo tentando di rimediare alla stagnazione (incompresa nelle sue cause) dell’accumulazione.
Nacque così l’economia dell’indebitamento generalizzato e delle bolle finanziarie che si protrae fino ad oggi e che la teoria ufficiale volle intendere addirittura come un nuovo paradigma economico in cui sia i consumi che la produzione vengono sostenuti da valore fittizio mentre il potenziale inflazionistico resta confinato alla sfera finanziaria. La crisi del 2008 e il ritorno dell’economia del debito pubblico, del QE etc. ormai insostenibile a lungo termine e il ritorno drammatico dell’inflazione sono solo l’ultimo capitolo di questa crisi.
Samuele Cerea
—–
XVII. La duplice devalorizzazione del valore. Verso la crisi storica del denaro
Il sistema dello sdoppiamento della merce in valore e valore d’uso e del valore stesso in merce e denaro si riproduce inevitabilmente anche nella crisi e nel suo concetto. A sdoppiarsi è pertanto anche la devalorizzazione del valore o la desostanzializzazione del denaro, che si impone sia sul livello della produzione di merce (devalorizzazione del capitale umano, del capitale fisico e del capitale in forma di merce), sia su quello dell’equivalente generale (devalorizzazione del medium fine-a-se-stesso del denaro). Questi due differenti processi di devalorizzazione non si sviluppano in modo omogeneo ed unitario nelle singole fasi della crisi, dal momento che non è il capitale della società nel suo complesso a subire in forma immediata il processo di crisi e a collidere con i suoi limiti, ma questo processo si dà empiricamente attraverso il movimento dei singoli capitali sulla superficie del mercato mondiale.
La devalorizzazione si concretizza dunque su livelli differenti. Il primo è quello della produzione capitalistica o dei suoi singoli elementi. Quando scoppia la crisi dapprima si devalorizza la forza-lavoro come parte integrante del capitale in seguito alla riduzione dei salari e di altre remunerazioni oppure a causa dei licenziamenti («disoccupazione»). L’eliminazione progressiva della sostanza del valore, dovuta alla sempre minore possibilità di impiegare la forza-lavoro, si converte nella liquidazione prepotente della possibilità stessa di impiego. In apparenza il capitale fisico o costante continua a valorizzarsi ancora per un certo periodo ma dopo una fase di incubazione più o meno lunga anch’esso si inattiva a causa della chiusura degli impianti di produzione o del fallimento del singolo capitale che ne è la base. Più tardi o simultaneamente la crisi affiora alla superficie dei mercati; si accumula così una grande quantità di merce ormai invendibile che pertanto si devalorizza anch’essa con la fine della «validità» capitalistica dei beni d’uso, assolutamente disponibili sul piano concreto ma impossibili da trasformare in denaro. Una volta che questo processo di devalorizzazione di forza-lavoro, capitale fisico e di capitale in forma di merce si è innestato e progredisce fino a un certo grado, si manifestano le cosiddette «sovracapacità» della produzione, già descritte, che però sono tali solo alla luce dei criteri fine-a-se-stessi del capitalismo, non certo in rapporto alle necessità; com’è ovvio, nella misura in cui tali «sovracapacità» vengono gradualmente inattivate o eliminate, si inaridisce anche il flusso dei nuovi investimenti in termini di forza-lavoro e capitale fisico, ormai insensati dal punto di vista del capitalismo.
A questo punto gli utili realizzati nei periodi produttivi precedenti, il nuovo capitale monetario, si dirigono in quantità sempre minore verso gli investimenti reali, capitalisticamente produttivi, incanalandosi giocoforza nei mercati finanziari, dove si valorizzano ulteriormente, a prima vista indipendentemente dai processi di produzione reali. Mediante il sistema bancario il capitale monetario inutilizzato viene prestato agli attori di mercato, già in sofferenza su tutti i livelli, ad un tasso di interesse sempre maggiore – facendo sì che la loro insolvenza venga dilazionata nel tempo – e/o collocato sui mercati azionari o immobiliari sotto forma di titoli, spingendo verso l’alto i loro prezzi. In questo modo i possessori dei più diversi titoli obbligazionari o azionari «si credono ricchi», stimolando indirettamente la produzione e la vendita, in assenza di qualsiasi fondamento nella sostanza reale del valore. Dopo qualche tempo però le bolle creditizie e finanziarie, gonfiate artificialmente e desostanzializzate, finiscono necessariamente per esplodere. Ne consegue, su di un secondo livello, la devalorizzazione del capitale finanziario gonfiato nella forma della crisi del debito e del crollo borsistico, che si ripercuote a sua volta sui mercati delle merci e del lavoro, causando una possibile accelerazione in caduta libera della spirale discendente.
Questa descrizione sommaria della devalorizzazione di tutti gli elementi del capitale (capitale monetario, forza-lavoro, capitale fisico, merci) fa riferimento al valore sul livello della società complessiva; sul piano empirico, tuttavia, il processo assume una forma più complessa, intermittente, asincrona nei suoi singoli momenti e con fasi temporanee di inversione, legittimando così fino all’ultimo, alla luce di un’analisi superficiale, interpretazioni completamente differenti (in cui trionfa di solito l’ottimismo deontologico delle istituzioni).
Un ulteriore problema consiste nel fatto che, sempre sul piano empirico, è possibile identificare tali momenti, in relazione a singoli capitali o a determinati settori e segmenti dei mercati delle merci e del lavoro, non solo durante una crisi ma anche nel corso della più che ordinaria riproduzione capitalistica. La quotidianità borghese è fatta di difficoltà relativamente agli sbocchi sui mercati, alla ristrutturazione di prestiti, fallimenti, licenziamenti etc.; è solo quando raggiungono una massa sociale critica, ossia un certo grado di generalizzazione, che tutti questi fenomeni sfociano in una crisi manifesta, evidenziando così il limite interno sul livello occulto del valore, impossibile da rilevare direttamente. Ma diversamente da quanto ritiene il pensiero positivistico, la crisi non è l’esito di una sommatoria di problemi che affliggono i singoli capitali. È vero l’esatto contrario: è la crisi o il limite interno della valorizzazione sul piano della società complessiva, nel modo in cui si realizza alle spalle degli attori, a creare queste difficoltà nella riproduzione dei singoli capitali, aggregandoli fino a raggiungere la massa critica. Poiché la causa ultima della crisi consiste nella contrazione della massa sociale complessiva del valore e del plusvalore, oggetto di contesa per i partecipanti alla concorrenza, i singoli capitali «più abili» si tengono a galla, almeno fino ad un certo grado, a spese degli altri (e attraverso la «cura dimagrante» di cui parleremo nell’ultimo capitolo); tuttavia non c’è un singolo capitale che possa eludere l’insieme delle sue condizioni sociali e questo fa sì che, alla fine, la devalorizzazione, quando oltrepassa quel grado, paralizzando gradualmente la riproduzione sociale come un intero, colpisce anche il novero sempre più ristretto dei vincitori della crisi.
Durante l’ascesa storica del capitalismo però nessuna crisi ha mai raggiunto quel grado, o comunque, mai per un periodo di tempo abbastanza lungo (come fu il caso, soprattutto, della crisi economica mondiale degli anni Trenta) e limitatamente a certi paesi o a certe regioni del globo. Fino a quando continuò a funzionare il meccanismo di compensazione, già discusso e esaminato in precedenza, basato sull’espansione esterna ed interna del capitale e legato alla produzione del plusvalore relativo, e finché le stagnazioni e perfino i drastici crolli dell’accumulazione vennero superati grazie alla crescita dell’assorbimento di forza-lavoro supplementare capitalisticamente produttiva, la produzione di nuove masse di plusvalore poté anche bloccare il processo di devalorizzazione in tutti i suoi momenti, ancora una volta in una serie di fasi asincrone e contraddittorie.
In tali condizioni anche le bolle creditizie e finanziarie erano sempre di breve durata; talvolta la loro esplosione segnalava addirittura l’inizio di una nuova crescita reale della massa di plusvalore. E così, nella fase di passaggio, i capitali più scaltri passavano dalla «cura dimagrante» ad un’enorme espansione aziendale, magari acquistando per un tozzo di pane le parti di altri singoli capitali, devalorizzate in seguito al fallimento economico ma ancora in grado di funzionare conformemente allo standard di produttività vigente. I fatti qui esposti, ben noti sul piano empirico, da cui si origina l’illusione che si debba attraversare ciclicamente un «punto zero» della valorizzazione, fanno parte anche del repertorio delle ordinarie teorie borghesi e marxiste della crisi, la cui forma «scientifica» è data dal positivismo e dall’individualismo metodologico, che invece di argomentare sul livello categoriale del capitale complessivo (o del «processo complessivo» in Marx), preferiscono assumere il punto di vista del capitale singolo o, più in generale, del singolo attore economico (incluso lo Stato).
Fino a quando fu possibile arrestare sistematicamente la devalorizzazione del valore o la desostanzializzazione del capitale, nonostante lo sviluppo della contraddizione interna, prima che le relative conseguenze logiche fossero spinte all’estremo, invertendo la rotta, sembrava sempre che il problema fosse stato risolto. Ma la dinamica progressiva del capitale avrebbe necessariamente concretizzato l’incombente logica finale della devalorizzazione, dapprima solo in via indiretta, su di un piano sempre più elevato di questa contraddizione. Anche sotto questo riguardo, ben prima della maturazione completa della crisi con la Terza rivoluzione industriale, si vede bene come il capitalismo non sia affatto un «eterno ritorno dell’uguale». Marx aveva già identificato, nei suoi tratti fondamentali, un aspetto di questa incessante mutazione qualitativa – la legge della caduta tendenziale del saggio del profitto. L’altro lato del medesimo processo – l’espansione storica del credito, che si colloca sul livello fenomenico del denaro – e la sua conseguenza logica – cioè la devalorizzazione del medium del denaro – non si trova quasi in Marx, o solo in qualche accenno.
Questo perché all’epoca di Marx (l’inizio della seconda metà del XIX secolo) l’aumento del rapporto c/v [capitale fisico/forza lavoro] – che sta alla base della legge della caduta tendenziale del saggio del profitto, ossia l’aumento dell’intensità del capitale, sebbene già visibile sul piano empirico e già descritto nella sua logica, non aveva mai raggiunto la soglia critica oltre la quale si sarebbe manifestato il suo rovescio nel sistema del denaro e del credito. Si poteva quindi osservare il processo nei suoi tratti fondamentali solo sul lato della produzione, non su quello della merce-denaro e del suo movimento pseudo-autonomo nel credito – o almeno non in maniera altrettanto conseguente. In ogni caso, Marx non seppe ancora sviluppare questa logica con altrettanta lucidità sul piano concettuale e analitico. La causa va ricercata ancora una volta nel carattere processuale e quindi storico della categorie reali del capitalismo, che per l’interpretazione teorico-concettuale, con la sua inclinazione verso l’astrazione astorica (consueta nel marxismo e nella Neue Marxlektüre), risulta problematico constatare. Di fatto la comprensione di tale storicità non è mai in grado di annullare del tutto la relazione tra la teoria e la posizione storica dei suoi ideatori e questo fa sì che l’unità tra determinazione concettuale e analisi storica non possa mai essere perfetta.
Qual è ora la circostanza che esprime la caduta (relativa) del saggio del profitto, dapprima in termini altrettanto relativi, all’interno del sistema del denaro? Sappiamo già che la crescita del rapporto c/v, l’aumento della composizione organica del capitale, fa sì che sul piano sociale complessivo del valore, la quota della forza-lavoro (v), l’unica in grado di generare nuovo valore, decresca in termini relativi rispetto al capitale monetario impiegato mentre crescono in termini relativi i costi del capitale fisico (c), riferiti al mero aggregato materiale, infruttuosi per l’ulteriore accumulazione di «ricchezza astratta». La conseguenza per il singolo capitale empirico è che i costi preliminari complessivi aumentano parallelamente all’aumento dell’intensità di capitale, ossia che gli è necessario investire più capitale monetario per far funzionare una certa combinazione redditizia c/v, in grado di competere per le quote di mercato.
C’entra inoltre il fatto che, con l’aumento della quota di (c) sul piano del capitalismo complessivo, oltre al grado generale della socializzazione capitalistica, crescono anche la divisione funzionale, l’integrazione verticale e l’infrastruttura delle singole imprese. Il processo di concentrazione e centralizzazione del capitale, descritto da Marx, non è solo la conseguenza formale della concorrenza ma anche la conseguenza sostanziale sul piano materiale dell’applicazione della scienza e della tecnologia. Nella fase dell’innovazione è senz’altro possibile che nuovi prodotti o nuovi rami produttivi sorgano a partire da piccoli inizi; poi però si passa con rapidità sempre maggiore alla produzione ad elevata intensità tecnologica, materiale e organizzativa, con le relative strutture su grande scala, non più nel giro di qualche generazione ma già all’interno di quella dei fondatori.
Neppure l’«outsourcing» delle singole funzioni aziendali, praticato negli ultimi tempi e in modo militante, può cambiare minimamente le cose. Questo metodo è solo la conseguenza dell’enorme intensificazione della pressione dei costi, i quali però vengono solamente distribuiti su scala più ampia; si tratta solo del modo in cui l’ottuso calcolo aziendale, sul livello del singolo capitale empirico, tenta di aggirare «furbescamente» un problema che però, sul livello sociale complessivo del valore, rimane del tutto irrisolto. L’affannarsi globalizzato sull’«outsourcing» non c’entra nulla con l’innovazione di prodotto, con la nascita di nuove piccole imprese o di nuovi settori economici autonomi in quanto si tratta solo di un programma per la riduzione dei costi del capitale concentrato e globalizzato mediante imprese di second’ordine, solo formalmente indipendenti, con lavoratori pseudo-autonomi o dipendenti di seconda e terza classe esclusi dalla contrattazione collettiva (sotto questo aspetto il Giappone ha funzionato da battistrada già in tempi meno recenti). Il problema dell’aumento dei costi preliminari e la necessità di un investimento sempre maggiore di capitale monetario vale però anche per le piccole imprese dell’«outsourcing», le quali sopravvivono senz’altro solo in virtù dei bassi salari o di un autosfruttamento sovraproporzionale, ma hanno costi in termine di capitale fisico (crescente) legato alla loro funzione, comunque destinati a progredire. Inoltre la mitigazione dei costi mediante la devoluzione delle proprie funzioni aziendali a imprese a bassi salari non è poi così importante per il «capitale-madre» effettivo in quanto la quota relativa dei costi salariali diminuisce costantemente sia per le singole funzioni aziendali sia per il capitale nel suo complesso.
Sul piano del singolo capitale empirico il problema della crescita dell’impiego di capitale monetario per i costi preliminari di una produzione di profitto ben riuscita divenne significativo solo all’inizio del XX secolo, ossia durante i primi stadi della Seconda rivoluzione industriale (taylorismo/fordismo), circa trent’anni dopo la morte di Marx. Prese così le mosse un processo qualitativamente nuovo, che si caratterizzava essenzialmente per la sempre maggiore rilevanza e necessità del credito al fine della produzione di plusvalore e profitto, nonché per l’espansione del sistema creditizio.
Naturalmente il credito – e con esso il capitale produttivo di interesse – giocava un ruolo già all’inizio dello sviluppo capitalistico. La relazione generale tra il sistema creditizio e il modo di produzione capitalistico era già stata descritta da Marx, soprattutto nel terzo libro del Capitale; ad esempio l’interesse vi appare come una forma derivata del plusvalore prodotto: attraverso il sistema creditizio i rappresentanti del «capitale funzionante» (cioè del capitale produttivo), devono cedere una parte di questo capitale, nella forma dell’interesse, al capitale finanziario creditore. In una prima fase questa necessità si faceva sentire in maniera rapsodica, ad esempio durante la costituzione di una nuova impresa o nel caso di una forte espansione della produzione, oppure a causa di situazioni problematiche o critiche, della mancanza di una quantità sufficiente di risorse interne per gli investimenti etc. Anche lo Stato, la cui genesi fu contemporanea a quella del feticcio capitalistico, fece ricorso fin dal principio al capitale a credito, soprattutto per il finanziamento degli armamenti e della guerra, a partire dalla rivoluzione militare delle armi da fuoco (a questo proposito si vedano i cap. VI e VII). Il capitale monetario di cui necessita il credito proviene dai risparmi privati dei membri della società, inclusi i lavoratori salariati, da patrimoni passivi variamente accumulati, nonché dalle riserve che i singoli capitali non sono momentaneamente in grado di impiegare produttivamente; esso si concentra principalmente nelle banche che, a loro volta, lo concedono in prestito (naturalmente sono possibili anche forme di credito privato). A questo proposito Marx non si limitò a dedurre la determinazione economica generale della forma del credito ma si occupò anche delle relative mistificazioni che influiscono sia sulla contabilizzazione delle imprese sia sul «pregiudizio popolare». Si riferiva qui all’apparente «qualità occulta» del capitale produttivo di interesse di generare più denaro direttamente dal denaro (G-G’), dovuta al fatto che il nesso con la produzione di plusvalore reale risulta invisibile per una coscienza fissata sulla superficie del mercato.
Anche l’esistenza generale del capitale monetario produttivo di interesse o del credito ha il carattere di un processo storico e pertanto, come si è già accennato, è necessario descriverla concettualmente nel miglior modo possibile, compatibilmente con la posizione storica in seno allo sviluppo capitalistico. Lo stesso Marx aveva già compreso che il sistema creditizio, con l’aumento della socializzazione e della scientificizzazione della produzione, assumeva un’importanza sempre maggiore, convertendosi nel volano degli sviluppi successivi, ad esempio con la nascita delle società per azioni. Non fu però in grado di collegare sistematicamente questa tendenza con il problema della caduta del saggio del profitto, né con il limite interno finale e con la devalorizzazione del valore come tale.
Nel corso del XX secolo, in seguito alla caduta del saggio del profitto e alla crescita dell’intensità di capitale, emerse effettivamente la sempre maggiore necessità di capitale monetario in quanto risultava sempre più difficile coprire l’aumento incessante dei costi preliminari soltanto con gli utili correnti. In altre parole: i singoli capitali riuscivano sempre meno a costituire riserve sufficienti per gli indispensabili investimenti in capitale fisico solo sulla base dei propri profitti. Questo problema si aggravò ulteriormente in seguito all’accelerazione dello sviluppo tecnologico causato dalla scientificizzazione; le innovazioni di prodotto e le nuove tecnologie produttive di base agirono su scala sempre maggiore, passandosi il testimone a ritmo sempre più serrato e velocizzando per giunta anche il processo che Marx aveva definito come l’«usura morale» del capitale fisico. Con questa espressione si intende la necessità di ammortizzare e sostituire mezzi di produzione ancora integri sul piano della funzionalità tecnica poiché non più in grado di rispettare gli standard sociali della produttività già modificati da nuove tecnologie, metodi di controllo e processi.
In pratica fu sempre più difficile per i singoli capitali, anche per i più forti, rifinanziarsi adeguatamente solo in virtù dei profitti realizzati nei processi produttivi del passato. Nonostante le resistenze iniziali il ricorso duraturo al sistema creditizio divenne una conditio sine qua non per continuare a fare profitti e restare sul mercato. Ma poiché nel capitalismo il credito e il capitale produttivo di interesse esistevano da sempre, sia la teoria borghese che il marxismo giudicarono (e giudicano tuttora) queste forme come astoriche o perlomeno si volle credere (è il caso di Hilferding) che l’importanza crescente del credito assecondasse solo la crescita della socializzazione capitalistica e dell’attività produttiva in genere (l’ennesima inversione tra il livello astratto del valore e quello materiale dei valori d’uso). Nessuno provò a riflettere sul salto qualitativo nella funzione del credito per la riproduzione capitalistica, per non parlare della potenzialità di crisi insita in questo sviluppo.
Una volta però che il credito – e dunque il ricorso a capitale monetario esterno, inutilizzato da parte dei capitali produttivi – da fenomeno marginale o esigenza sporadica si converte nell’architrave della produzione futura, oltretutto su di una scala sempre maggiore, anche l’asse temporale della produzione di plusvalore sociale si sposta fondamentalmente dal passato al futuro. Se ci rendiamo conto, con Marx, che la presunta qualità occulta del capitale produttivo di interesse – quella di generare più denaro dal denaro – è solo il frutto di un’illusione ottica sulla superficie del mercato, poiché alla sua base c’è in realtà l’assorbimento di plusvalore reale, allora non è possibile dimenticare che questo plusvalore non è certo il risultato della sottoscrizione del credito, che lo si dovrà produrre con successo nel futuro; se così non fosse non ci sarebbe alcun bisogno del credito.
Vi è quindi un’enorme differenza tra un capitale che si rifinanzia ricorrendo prevalentemente a plusvalore passato già realizzato (ad esempio sotto forma di riserve) e un capitale che invece ricorre prevalentemente a una produzione di plusvalore futuro nemmeno iniziata, né tantomeno realizzata (nella forma del credito). Queste forme di rifinanziamento si possono senz’altro mescolare ma l’aumento relativo della seconda (analogamente alla crescita relativa della quota di c nella composizione organica del capitale) rappresenta, come nel caso del saggio del profitto, una mutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa.
Tale spostamento contiene un ovvio potenziale supplementare di crisi. Infatti, mentre il profitto realizzato durante i periodi produttivi del passato è una grandezza certa, quello futuro, non ancora realizzato, è totalmente incerto. È però necessario, naturalmente, servire il credito ottenuto, che si estinguerà dopo un certo intervallo di tempo, pagando nel frattempo gli interessi. Pertanto i singoli capitali, costretti a ricorrere in maniera sempre più insistita al credito, devono appropriarsi di una quota del plusvalore sociale, che sia sufficiente a onorare i propri debiti, ottenendo inoltre un profitto. Quando questa condizione diviene generale, aumenta la pressione sui singoli capitali e sorge anche un «problema sistemico»: siccome la possibilità di rifinanziamento, in ultima analisi, non dipende più dalla produzione di plusvalore del passato ma da quella futura, non è più sufficiente una crescita incessante della massa del plusvalore poiché quest’ultima deve essere inoltre abbastanza imponente affinché l’anticipazione di questo plusvalore nel passato non pregiudichi la prosecuzione della riproduzione nel presente.
In altre parole: sebbene l’espansione del capitale complessivo sia prosperosa e la massa di plusvalore cresca in continuazione, la cesura temporale tra la produzione anticipata di plusvalore e quella realmente conseguita si ingrandisce sempre di più. Il capitalismo inizia a consumare il suo futuro. Le catene creditizie si allungano ma diventano sempre più fragili, sebbene di plusvalore ce ne sia in abbondanza. Possono infrangersi in qualsiasi momento e questo accade effettivamente, in qualche singolo caso, ogni giorno e su scala sempre maggiore. In questo modo però non aumenta solo il rischio per ogni singolo capitale partecipante al mercato, sempre più finanziato a credito, ma anche il rischio «sistemico» di un crollo del sistema creditizio, magari temporaneo (finché perdura la fase di espansione) sul piano del capitalismo complessivo. In sostanza, questo significa che l’astratto potenziale di crisi insito nella separazione nel tempo e nello spazio degli atti di acquisto e di vendita, già previsto da Marx nel primo libro del Capitale, si consolida storicamente sul livello del sistema creditizio; lì infatti l’accensione del credito e il suo successivo rimborso si separano ancora più nettamente, su scala sempre più estesa e in modo strutturale.
Questo problema, collocato sul livello del capitale monetario e generato dallo sviluppo capitalistico stesso, sollevò generalmente la questione del ruolo della merce-denaro in un sistema creditizio in costante espansione. L’assicurazione basata sullo standard aureo, ossia sulla convertibilità in oro della moneta, iniziò a rivelarsi onerosa in quanto frenava l’estensione delle funzioni formali del denaro nell’ambito del credito, causando la contrazione strutturale del suo volume. Pertanto, già nell’ultima parte del XIX secolo, il dibattito relativo alla teoria e alla politica monetaria – che si riaccese ulteriormente all’inizio del XX secolo – si focalizzò, oltre che sul carattere della merce-denaro, anche sulle banche centrali di emissione. Nella maggior parte dei paesi, in seguito alla progressiva realizzazione ed espansione della società capitalistica, le banche centrali divennero istituzioni statali. In quanto presunto «debitore infallibile» dalla credibilità apparentemente illimitata, in virtù della sua prerogativa «sovrana» di disporre delle risorse nazionali, lo Stato venne promosso a garante politico dell’emissione di moneta cartacea e scritturale da parte delle banche centrali.
Si moltiplicarono le voci che insistevano per la sostituzione integrale del legame con l’oro, come merce-denaro reale, con la garanzia statale. Nel mondo accademico l’esponente classico di questa tendenza fu Georg Friedrich Knapp con la sua Teoria statale del denaro (Knapp 1905). Da quel momento cominciò a livellarsi la differenza tra la prima teoria neoclassica – che si basava ancora su di una merce-denaro «desostanzializzata», come lo erano del resto anche tutte le altre merci – e il nominalismo puro e semplice (vedi il cap. II). Questa linea venne sistematicamente assecondata dai principali esponenti della teoria neoclassica del XX secolo, i cosiddetti neoliberali, che continuarono a svilupparne le determinazioni teoriche.
Sul piano empirico, molto prima di raggiungere l’apice nella riproduzione capitalistica «normale», questo problema conobbe un’evoluzione drammatica nelle economie di guerra dell’epoca dei conflitti mondiali. A quei tempi la crisi del medium fine-a-se-stesso del denaro fu causata direttamente dal ricorso al plusvalore futuro da parte dello Stato nella sua veste di «signore della guerra», non da parte dei singoli capitali. In linea di principio non c’era poi nulla di nuovo: abbiamo già detto come l’indebitamento dello Stato per finanziare gli eserciti e le guerre (che era stato certamente la causa di diversi fallimenti statali) era stato da sempre un elemento della storia della costituzione del capitalismo, in tutti gli stadi del suo sviluppo. In quanto debitore impossibile da perseguire, in virtù della sua autorità e del monopolio della violenza, lo Stato, se faceva bancarotta, dissanguava la propria popolazione, anche se talvolta erano stati i creditori ad essere espropriati. Ma all’inizio del XX secolo la situazione era radicalmente mutata sotto due punti di vista.
Infatti a quell’epoca, da un lato, il credito statale e la riproduzione capitalistica della società non erano più due entità relativamente estranee l’una all’altra ma si erano strettamente incastrate e combinate tra loro come due ruote dentate. Siccome la valorizzazione del capitale costituiva ormai da tempo la base economica dello Stato e la logica capitalistica si era affrancata anche nei confronti dello Stato stesso, quest’ultimo non poteva più né strangolare la riproduzione capitalistica della popolazione, ormai diffusasi in maniera pervasiva, né tantomeno rovinare i propri creditori nel contesto di un sistema finanziario estremamente socializzato. Se lo Stato, oltre che attingere alle sue regolari entrate tributarie, prelevate dalla ricchezza originata da una produzione reale di plusvalore – che per giunta non potevano oltrepassare una certa misura per non impedire la suddetta riproduzione -, ricorreva al credito, esso doveva anche rispettare regolarmente le sue leggi sistemiche, come tutti coloro che sottoscrivevano crediti (singoli capitali e privati).
D’altro canto, a partire dal 1914, divenne chiaro che la guerra industrializzata, con i suoi apparati tecnologici e le sue titaniche battaglie di materiali, aveva sbaragliato nel giro di pochissimo tempo ogni ordinaria possibilità di finanziamento. Anche la macchina dello sterminio, fondamentalmente improduttiva per il capitalismo, aveva sperimentato un immane aumento del rapporto c/v: per partecipare al prolungamento della concorrenza con altri mezzi sul campo di battaglia, bisognava conformarsi allo standard di produttività nel settore della distruzione omicida. Agli Stati restarono solo due alternative: da una parte l’estinzione della vita sociale, la fame di massa per la popolazione e la riduzione del capitale all’industria bellica; dall’altra l’intervento sul piano monetario mediante strumenti fino a quel momento inimmaginabili. Ciò che si ebbe fu, in effetti, una miscela catastrofica di entrambe le opzioni.
Le banche centrali si prepararono così a disinnestare per forza lo standard aureo, ossia la convertibilità del denaro in oro, violando tutte le regole precedenti in materia di emissione di moneta cartacea e scritturale. Lo Stato non era più in grado di finanziare la guerra mondiale industrializzata attraverso regolari entrate tributarie, né con l’accensione regolare di crediti sui mercati finanziari (ossia prendendo a prestito capitale monetario a interesse, generato da processi di valorizzazione reale del passato, sotto forma di risparmi, riserve e patrimoni passivi). Costrinse invece la propria banca di emissione a trasferirgli direttamente nuovi surrogati del denaro creati dal nulla, con i quali poté regolare gli enormi costi della guerra e che poi, naturalmente, circolarono come denaro tramite le entrate dei corrispondenti processi produttivi, l’impiego della macchina dello sterminio, le spese amministrative etc.
Ne fu la conseguenza, come è noto, la perdita di valore del denaro nel corso di ondate più o meno rapide e imponenti. Dopo la Prima guerra mondiale l’inflazione e l’iperinflazione sconvolsero brutalmente e durevolmente la riproduzione capitalistica; un fenomeno che, ovviamente, fu particolarmente drammatico nella Germania sconfitta. Come si è già brevemente accennato (nel Cap. II) Marx non conobbe tale fenomeno, per lui addirittura inconcepibile. Adesso ne si comprende anche la ragione. La tendenza verso l’aumento della composizione organica del capitale e la caduta del saggio del profitto, da lui descritte, ebbero ripercussioni qualitative sulla forma-denaro e sul sistema del credito solo qualche decennio dopo la sua morte e, anche in quel caso, non si ebbe una crisi generale da devalorizzazione; infatti la causa immediata fu la crescita specifica del rapporto c/v nell’improduttivo complesso militare-industriale, con la sua mobilitazione generale.
Sul piano qualitativo questa devalorizzazione del denaro era un fenomeno assolutamente nuovo; sin dall’inizio dell’età industriale, ossia da quando il capitale aveva iniziato a svilupparsi sulle «proprie basi» (Marx), non solo non si era mai verificata una devalorizzazione interna del denaro ma c’era stata inoltre la garanzia istituzionale del suo carattere sostanziale in virtù della fissazione metallica, l’istituzione dello standard aureo e la costituzione di un sistema di banche centrali pubbliche su questo fondamento. Né è lecito il paragone tra l’inflazione del XX secolo e la «corruzione della moneta», operata dai Prìncipi agli albori dell’era moderna, o la svalutazione delle prime emissioni di denaro cartaceo. Questo perché quell’inflazione consisteva in una devalorizzazione del denaro su base industriale, nel quadro di una generale espansione storica del credito, che abbracciava integralmente la riproduzione di una società totalmente capitalistica.
Neppure la grande crisi economica mondiale (1929-1933), scolpitasi nella memoria collettiva come lo sconvolgimento più profondo e di più vasta portata del capitalismo fino a quel momento, fu dovuta alla devalorizzazione interna del capitale su grande scala e in tutte le sue forme. Essa infatti, da un lato, fu solo una crisi strutturale passeggera nella transizione verso l’espansione fordista – per la quale i tempi non erano ancora maturi – e l’aumento della massa assoluta del plusvalore – che si innestò a pieno regime solo dopo la Seconda guerra mondiale. Dall’altro, la grande crisi di quell’epoca fu resa ancora più grave dalle conseguenze non ancora sanate della Grande guerra, incluso il tracollo del sistema monetario in seguito all’inflazione. In un primo momento alcuni paesi avevano cercato di ricostituire lo standard aureo. Ma tutti questi tentativi fallirono nel giro di breve tempo, e non solo perché la Seconda guerra mondiale superò di gran lunga la precedente in termini di applicazione tecnologica e di consumo di materiali. Già a quel tempo la scientifizzazione della produzione aveva il suo rovescio nella scientificizzazione della macchina dello sterminio, il cui esito fu una nuova valanga di costi: un processo che, del resto, continua anche ai giorni nostri.
Ma a scatenare le più o meno possenti ondate inflazionistiche, le cesure o le riforme monetarie con la scomparsa totale delle vecchie unità valutarie (ancora una volta in maniera particolarmente drastica in Germania) non fu solo il secondo round dello sterminio industriale globale di massa. Accadde invece che il potenziale inflazionistico, causato dal finanziamento del complesso militare-industriale scientificizzato e della conduzione bellica ad alta intensità di impiego materiale in virtù della creazione di moneta da parte delle banche centrali e/o sulla base del credito, si intrecciò con l’espansione generale del credito presso i singoli capitali e bilanci privati: un tema su cui la teoria del denaro e del credito non seppe riflettere adeguatamente. Si evidenziò inoltre come l’incessante prolungamento delle catene creditizie il ricorso sempre più ingente alla produzione di valore futuro, per il momento solo virtuale, indipendentemente dai costi della guerra, fossero già di per sé un fattore di destabilizzazione per il sistema monetario globale, rendessero utopico il ripristino dello standard aureo e racchiudessero al loro interno un potenziale inflazionistico. Con l’abolizione definitiva dell’ultima forma di convertibilità aurea, quella relativa al dollaro, per quanto indebolita e valida solo per i soggetti statali e istituzionali, si sgretolò la base del medium fine-a-se-stesso capitalistico.
Le cose però non vennero interpretato in tal senso; infatti il potenziale di crisi insito in questo processo e il suo legame con una tendenza complessiva verso l’autodevalorizzazione del capitalismo vennero completamente ignorati. Ciò che la scienza e il senso comune poterono e vollero vedere attraverso le loro lenti positivistiche, fu solo un nuovo «fatto» monetario: il denaro si era liberato della sua sostanza e dalla sua base metallica (superficialmente considerata), continuando a funzionare anche senza la copertura aurea. Non poteva che essere così. Buone notizie per l’espansione del credito e per un capitalismo liberato dai gravosi vincoli della sua materia-denaro. L’impressione era dunque che le vecchie teorie del denaro – ma soprattutto, come è logico, quella di Marx – peccassero tutte di «sostanzialismo». È la prova di come la coscienza affermativa, imbevuta di mentalità positivistica, tende sempre a ridefinire tutti i fenomeni che segnalano un limite interno assoluto del capitalismo come altrettanti mutamenti positivi e autosufficienti del capitalismo, almeno fino a prova contraria (ma talvolta anche oltre). Ciò presuppone, in ultima analisi, l’inesistenza di una legalità interna oggettivata del capitale come rapporto feticistico, che si riduce invece alla risultante delle lotte soggettive per l’interpretazione e dei rapporti di potere.
Questa visione gravemente deficitaria fu possibile solo in quanto (e fino a quando) la devalorizzazione del valore (analogamente alla caduta del saggio del profitto) procedeva a passi lenti, anche se con fasi acute già pericolose. Astraendo dalla causa, inizialmente legata solo all’economia di guerra – dietro alla quale si celava però un complesso di ragioni più profondo – si innestò un gigantesco processo secolare di inflazione che non si interruppe mai, pur attraversando certamente fasi di crescita disomogenee. Per esempio, nel 1790, secondo le stime degli storici dell’economia, un certo paniere composto di comuni generi alimentari e domestici costava negli USA 100 dollari. Nel 1913 il costo era di 108 dollari, restando pressoché invariato nel corso di più di un secolo. Nel 2008 esso era però salito a 2422 dollari. È il sintomo della drammatica cesura qualitativa nel carattere della merce-denaro capitalistica. Il processo storico di devalorizzazione del denaro influiva sistematicamente, in maniera più o meno energica, sulla vita quotidiana e sui bilanci empirici del capitale; ma si riteneva che questa inflazione secolare – che appariva senz’altro come un pericolo – fosse comunque controllabile, senza che venisse compresa il nesso interno.
A partire dagli anni Settanta (ossia dopo la fine della convertibilità aurea del dollaro), già ben al di là delle specifiche economie di guerra della prima metà del XX secolo, prese l’avvio una nuova avanzata globale dell’inflazione, che nel giro di un decennio produsse tassi di inflazione talvolta anche a due cifre e una serie di iperinflazioni nei paesi della periferia. Il fatto è che l’epoca effimera della prosperità fordista aveva condotto oltre che alla crescita della massa di plusvalore reale, anche all’espansione del credito su larga scala, parallelamente all’ulteriore aumento della quota del capitale fisico con la Seconda rivoluzione industriale, malgrado l’assorbimento simultaneo di forza-lavoro supplementare. Con l’esaurimento dell’espansione fordista e il rallentamento dell’assorbimento di forza-lavoro supplementare – poiché gli investimenti per la razionalizzazione stavano superando gli investimenti per l’espansione – si allargò anche la forbice tra la produzione anticipata di plusvalore e quella effettivamente realizzata. Le catene creditizio entrarono in tensione e gli Stati aggravarono il problema tentando di arrestare la caduta dei tassi di crescita alla buona maniera keynesiana, ossia mediante interventi pubblici e programmi sociali finanziati a credito. Ciò che si profilava era un programma inflazionistico, che aveva caratterizzato originariamente le economie di guerra, sull’intera stagnante riproduzione del capitale.
Occorre dire però che questa inflazione automatica, in un certo qual modo, procedette con il freno a mano tirato in quanto le banche centrali non stimolarono direttamente la congiuntura mediante denaro creato dal nulla, ricorrendo invece al «meccanismo idraulico» del credito (soprattutto statale), fingendo cioè che si trattasse di denaro temporaneamente inutilizzato in senso capitalistico, derivante da processi reali di valorizzazione del passato. Nei fatti c’era già stato un distacco strutturale tra la creazione di denaro delle banche centrali, non più fondata nella sostanza di valore, e la reale creazione di valore. Laddove anche il «meccanismo idraulico» venne disinnestato (come ad esempio in America Latina) e le banche centrali iniziarono ad agire come in un’autentica economia di guerra, l’iperinflazione e la conseguente rovina economica fecero nuovamente la loro comparsa.
Come è noto fu proprio questa nuova avanzata dell’inflazione – che si protrasse ben dentro gli anni Ottanta – a fornire il pretesto per la cosiddetta rivoluzione neoliberale nella politica economica e monetaria. La comprensione superficiale della scienza economica, del management, della politica e dei media, tutti uniti in un nuovo consenso universale, trasversale alle parti, fraintendendo clamorosamente il nesso causale dovuto alla mutazione nella riproduzione del capitale, attribuì l’incombente devalorizzazione del denaro soltanto all’espansione delle attività dello Stato con il relativo finanziamento a credito; quest’ultima però era solo la conseguenza dei problemi fondamentali della valorizzazione. Invece di ridare vigore a una creazione supplementare di valore ormai asfittica tutto ciò servì solo a trasferire il problema della crescita dei costi preliminari e della collegata produzione di una massa assoluta di plusvalore troppo esigua dal credito statale ai mercati finanziari.
L’effetto della deregolamentazione dei mercati finanziari non fu la mobilitazione di forza-lavoro, comunque non certo su basi capitalisticamente regolari, ma lo scatenamento di un processo di indebitamento globale su tutti i livelli, storicamente senza precedenti, non più frenato dal legame aureo, e la costruzione di un’architettura fatta di bolle finanziarie, anch’essa senza precedenti, fondata sull’indebitamento. Una volta disattivati tutti i tradizionali meccanismi di sicurezza, questo processo, diversamente da altri fenomeni analoghi strettamente limitati nel tempo, si trascinò per quasi due decenni; questo fece sì che l’abituale ottimismo deontologico lo interpretasse come l’avvento di una nuova era in cui le vecchie leggi economiche non erano più valide. Da quel momento la teoria dell’economia politica, tradizionalmente cieca nei confronti del suo oggetto, ha smesso di prendersi sul serio; un segnale d’allarme, questo, che però non sembra interessare a nessuno.
Sta di fatto che nell’era neoliberale dell’indebitamento e delle bolle finanziarie, la separazione tra la produzione di plusvalore reale e l’anticipazione fittizia del plusvalore stesso si è ampliata fino ad una misura addirittura grottesca. Le catene creditizie si allungarono come vermi parassiti, le operazioni basate sui contratti derivati divennero sempre più opache. Il consumo capitalistico del futuro acquistò una dimensione fantascientifica. Anche un bambino poteva accorgersi del fatto che il legame tra la riproduzione al presente e la futura produzione immaginifica di valore si sarebbe inevitabilmente spezzato una volta che la valorizzazione reale, nella reale sequenza temporale, fosse stata troppo debole per servire l’immane quantità di crediti accumulati su scala globale – una cambiale sul futuro per un ordine di grandezza astronomico – mediante continue ristrutturazioni del debito e la creazione di bolle finanziarie. Con l’ulteriore, enorme aumento del rapporto c/v alla base del capitale e la concomitante diminuzione della massa di lavoro produttivo, l’unico modo per finanziare la crescita altrettanto enorme dei costi preliminari era il ricorso costante alla produzione di valore futuro; come se non bastasse bisognava finanziare a credito anche la domanda per questa produzione finanziata a credito, non solo da parte dello Stato.
Non era più possibile chiudere la forbice tra il plusvalore anticipato e quello realmente prodotto. Lo testimonia anche il fatto per cui le esigenze del credito non venivano più soddisfatte mediante le riserve e i risparmi reali o i patrimoni generati dalla precedente produzione di plusvalore ma solo grazie alle bolle finanziarie rigonfiate dall’aumento fittizio del valore dei titoli sui mercati finanziari. La colossale estensione di questo processo, dovuta dapprima alla soppressione del legame con l’oro e poi alla deregolamentazione neoliberale dei mercati finanziari, fece sì che il pensiero positivistico (non da ultimo quello della sinistra) credesse seriamente che il capitalismo, nel suo processo di accumulazione presuntivamente eterno, fosse ora «trainato dalla finanza», qualsiasi cosa ciò potesse significare (la riflessione aveva smarrito la vera concatenazione interna o forse non l’aveva mai posseduta).
Sembrava quasi che questa costruzione storicamente inaudita, un’economia puramente fondata sul deficit, sulla base fittizia del consumo illusorio del futuro, fosse temporaneamente in grado di assumere una consistenza reale in forma secondaria, di sollevarsi con le proprie mani, al modo del Barone di Münchhausen, dal pantano dell’impiego insufficiente di forza-lavoro, mobilitando nel presente una quantità di risorse – tra cui, ancora una volta, la forza-lavoro – grazie all’anticipazione di profitti e redditi futuri, che mai sarebbero stati realizzati. Sorgeva così il dilemma per cui, da una parte, la forza-lavoro mobilitata era troppo scarsa per le esigenze della riproduzione al presente e per il servizio di un sistema creditizio ipertrofico mentre, dall’altra, la medesima forza-lavoro era invece sovrabbondante per la reale capacità di assorbimento della valorizzazione reale al presente. Detto altrimenti: rispetto alla condizione sul livello del valore, la quantità di forza-lavoro utilizzata era (e continua ad essere) di gran lunga eccessiva e su una base ormai irreale; astraendo dalle vere e proprie bolle debitorie e finanziarie, il risultato fu una produzione di plusvalore che pur apparendo reale non era affatto tale.
Questa assurdità reale, qui descritta in modo schematico, che sul livello categoriale si manifesta come un fenomeno ottico difficile da comprendere e su quello superficiale come una struttura complessa, estremamente articolata, è tuttavia banale nella sua logica ingannevole. Il fatto è che nell’espansione illimitata del capitale, nel ciclo delle sue metamorfosi, su cui si basa l’accumulazione, la lacuna che si apre sul piano del valore viene colmata provvisoriamente con un valore immaginario desostanzializzato e in maniera duplice: da un lato il credito deve surrogare la scarsità della domanda su di un ordine di grandezza insostenibile; dall’altro, data l’insufficienza del valore pseudo-realizzato, il credito deve surrogare anche i costi preliminari dei successivi cicli produttivi (impiego di macchinari, forza-lavoro etc.) per un ordine di grandezza altrettanto insostenibile. Mentre in apparenza il ciclo del capitale, nonostante qualche attrito, continua a funzionare, in realtà si spalanca una voragine tra il passato e il futuro della sostanza di valore.
Questo miraggio è ben visibile nel caso ormai celebre delle bolle immobiliari nelle economie interne di diversi paesi. Grazie all’aumento del prezzo dei titoli di proprietà – privo di sostanza e incessantemente gonfiato – si crea un boom nel settore delle costruzioni che, in un primo momento, appare reale; si tratta solo di un villaggio di Potjomkin fatto di «duri fatti economici» che però viene preso volentieri sul serio dall’ottusità del positivismo scientifico, dall’altrettanto ottuso senso comune dei maneggioni e, non poteva essere diversamente, dalla comprensione dei marxisti. Questi ultimi, come i loro sventurati fratelli borghesi, si chiedono: non si verifica forse qui la mobilitazione di un’enorme quantità di risorse, di materiali da costruzione, di mezzi di trasporto, di macchinari per l’edilizia? Inoltre c’è un mucchio di forza-lavoro che sgobba come un mulo, facendosi sfruttare senza ritegno. E allora come si fa a dire che qui non c’è una produzione reale di plusvalore? Solo quei forsennati, scollegati dalla realtà, dei sostenitori della teoria radicale della crisi potrebbero sottoscrivere una tale sciocchezza.
Ciò che vi è di diverso, anche se inizialmente inavvertibile alla superficie, ciò che i teorici ultra-realisti non vedono (non vogliono vedere) è che sono i presupposti stessi di tutta questa industriosa orgia lavoristica, che sembrerebbe regolare nella sua sostanza, ad essere falsi. Se non si ha denaro (valore) per i costi di produzione non si può veramente produrre, se non si ha denaro (valore) per la domanda non si può veramente consumare. Siccome crediti inesigibili e bolle finanziarie hanno surrogato artificialmente, da entrambi i lati, il corrispondente potere d’acquisto, la falsità del miracolo dovrà venire alla luce. Qua e là per il territorio vedremo allora «rovine da investimento», più o meno orripilanti, come artefatti «naturalmente» reali, che segnalano come non vi sia stata, però, nessuna produzione di valore e plusvalore, a prescindere da chi dovrà pagare per il disastro. La produzione apparentemente florida di utili con tutte le gincane della crescita di plusvalore assoluto e relativo si esaurisce con lo scoppio clamoroso della devalorizzazione; come nel caso spagnolo la pseudo-congiuntura, sorretta dalla bolla immobiliare, si rovescia automaticamente in una profonda recessione, accompagnata da un’esplosiva disoccupazione di massa, che mai avrebbe avuto luogo se ci fosse stata davvero una produzione di plusvalore reale.
Nella sua specificità la bolla immobiliare è però solo un aspetto in seno a una costellazione di problemi assai più ampia e generale che affligge l’economia capitalistica globale basata sul deficit, che è a sua volta il frutto del dilemma tra la formazione insufficiente della sostanza del valore, la crescita storica dei costi preliminari e il declino della domanda regolare. Al legame tra la bolla immobiliare e l’attività edilizia, sul piano dell’economia interna, corrispondono i circoli transnazionali del deficit tra diversi paesi e regioni del globo sul piano del mercato globale. Nell’impossibilità di esaminare dettagliatamente questo livello (cui penserà un’analisi specifica degli sviluppi del mercato mondiale a partire dalla Seconda guerra mondiale), ci limitiamo a dire che al centro c’è fondamentalmente il circolo deficitario del Pacifico tra l’Asia (in particolare la Cina) e gli USA, oltre al circolo deficitario europeo tra la Germania e il resto dell’UE o dell’Eurozona. In tutti e due i casi i famigerati «squilibri», accumulatisi nel corso di periodi lunghissimi, ad onta di tutti i manuali di economia politica, implicano un finanziamento basato sul deficit, in ultima analisi insostenibile, del consumo da una parte e della produzione dall’altra, il cui rovescio è dato dai flussi unilaterali delle esportazioni e delle importazioni. Il trucco alla Münchhausen consiste nel fatto che la produzione di eccedenze di qualcuno viene finanziata con i debiti di qualcun altro, che a sua volta acquista i beni prodotti dal primo proprio mediante l’indebitamento. Verrebbe da dire che tutti si finanziano vicendevolmente senza che però nessuno abbia realmente un soldo in tasca. Naturalmente il gioco può continuare solo fino a quando il denaro scritturale desostanzializzato sotto forma di titoli di credito non viene richiesto come mezzo reale di conservazione del valore.
Come le bolle immobiliari generano plusvalore apparentemente reale nel settore delle costruzioni, anche i circoli deficitari generano plusvalore apparentemente reale nelle industrie dell’esportazione dei paesi con eccedenze commerciali. E ancora una volta il pensiero positivistico prende questo mega-inganno per oro colato. Tutto il discorso circa l’ascesa dei cosiddetti «paesi di nuova industrializzazione» o della Cina come nuova presunta potenza mondiale, il «secolo del Pacifico» etc., è esclusivamente il frutto di questa percezione distorta, altrettanto deficitaria del suo oggetto.
Se la mobilitazione di forza-lavoro nell’industria delle costruzioni negli USA, in Spagna e altrove, alimentata dai buchi neri del non-valore, si è dissolta con la repentina devalorizzazione di questa forza-lavoro, dei suoi mezzi di produzione e dei suoi prodotti, la stessa devalorizzazione colpirà fatalmente anche gli enormi settori dell’esportazione dei paesi con eccedenze.
Se già il credito statale keynesiano, interamente rivolto verso l’economia interna, aveva fallito miseramente, anche la pseudocongiuntura neoliberale, alimentata dalle bolle creditizie e finanziarie transnazionali, fallirà ancora più miseramente. In sostanza il programma di deregolamentazione neoliberale si è tradotto in un keynesismo per i mercati finanziari su scala globale laddove la base del consumo capitalistico del futuro non è più lo Stato ma il finanziamento dei singoli capitali e dei consumatori grazie al credito e alle bolle finanziarie su di un ordine di grandezza ancora superiore. In un certo senso è come se una stamperia clandestina transnazionale avesse distribuito per il globo una quantità spaventosa di banconote contraffatte a vantaggio dei soggetti economici che allora, come è logico, iniziarono a produrre e a consumare in maniera selvaggia, ad un livello di produttività che non lo consentiva più, come se non esistesse un domani. E questo era effettivamente vero per un tale genere di vita.
La valanga di devalorizzazioni che si è abbattuta a partire dall’autunno del 2008 non ha rappresentato solamente un presagio di sventura per l’economia basata sul deficit ma l’inizio della sua fine e quindi il segnale del fatto che il limite assoluto del capitale è stato raggiunto. Se questa valanga poté essere temporaneamente arrestata lo si dovette solo al ritorno dell’economia del deficit pubblico, già fallita qualche decennio prima; ora però il problema ha assunto una dimensione di molte volte superiore. La crisi del debito statale, non più solo nella periferia ma anche nei centri capitalistici, negli USA e attualmente soprattutto nell’UE o nell’Eurozona, testimonia di come, nel complesso, il sistema monetario sia appeso a un filo. Dopo il fallimento di Lehmann Brothers le banche centrali hanno perso ogni freno inibitorio. Inondano l’economia con denaro privo di sostanza ricevendo in cambio come «garanzie» solo asset «tossici»; acquistano in massa obbligazioni di Stato prive di valore, senza neppure più preoccuparsi di passare attraverso il sistema bancario e gli investitori privati. Così facendo si sono trasformate in depositi di smaltimento per crediti inesigibili su di un ordine di grandezza di molti bilioni di unità monetarie. I pacchetti di salvataggio e i programmi congiunturali, messi a punto con l’aiuto delle banche centrali, hanno già raggiunto e superato la dimensione tipica delle economie di guerra.
Non appena si comincerà ad esigere le garanzie ancora sulle carte e le banche centrali, oltre a salvare in via presunta i mercati finanziari e ad occultare i crediti inesigibili, finanzieranno direttamente dal nulla, con le loro emissioni, la produzione e la domanda (come già si inizia a vedere), riprenderà anche la devalorizzazione, temporaneamente congelata, di tutti gli elementi del capitale mentre quella del medium fine-a-se-stesso del denaro assumerà una qualità nuova. Il keynesismo dei mercati finanziari aveva già generato un potenziale inflazionistico, che si stava manifestando nel 2008, quando venne momentaneamente sovrastato dallo shock da devalorizzazione del capitale monetario. Adesso, ancora una volta, in ossequio ai criteri classici, l’inflazione secolare verrà portata a compimento dallo Stato. Nell’economia globalizzata l’inflazione di una moneta può verificarsi oppure aggravarsi in seguito al crollo del suo valore esterno o alla devalorizzazione delle riserve monetarie dei paesi con eccedenze commerciali (con la Cina come caso più critico).
Un’indagine più minuziosa di questo processo di devalorizzazione esula dall’ambito di questa ricerca; se ne occuperà un’analisi specifica per la quale, comunque, l’orizzonte degli eventi non è più così remoto. Ci limiteremo qui a collegare lo sviluppo storico abbozzato qui, e il suo prevedibile apogeo, con il dibattito sulla teoria del denaro e del credito di Marx, traendone le dovute conseguenze. A questo scopo è illuminante il modo in cui e gli strumenti teorici con cui la Neuere Orthodoxie e la Neue Marxlektüre alla Heinrich si accostano al problema.
Si è già visto come Michael Heinrich abbia messo a punto una revisione della critica dell’economia politica di Marx, per quel che riguarda la teoria del valore e del denaro, che si colloca integralmente nel solco della teoria nominalistica borghese del denaro e che si armonizza particolarmente con la liquidazione teorica della merce-denaro a partire da Georg Friedrich Knapp, adottata nei suoi lineamenti fondamentali anche dalla successiva teoria neoclassica. Con la sua analisi filologica dell’opera di Marx egli ha gettato le fondamenta «critiche» per disinnescare il problema, convertendo la desostanzializzazione del capitale e del denaro come suo medium fine-a-se-stesso in una desostanzializzazione della teoria di Marx. In un secondo momento, la soppressione della teoria della caduta del saggio del profitto ostruisce definitivamente l’accesso alla dimensione di crisi insita nella teoria del denaro e del credito, da sviluppare oltre lo stesso Marx relativamente al nesso intrinseco tra l’aumento di c/v, la caduta del saggio del profitto e l’espansione storica del sistema creditizio.
Con la sua «scienza del valore», come pure in diversi scritti polemici estemporanei, Heinrich invece mira a destoricizzare anche il credito, inchiodandolo sul piano categoriale alla stregua di un «eterno ritorno dell’uguale». Ciò che viene presupposto qui è che qualsiasi riferimento ad una crescita dello squilibrio o della separazione tra la produzione reale di plusvalore e l’anticipazione di tale produzione mediante il credito nel processo storico del capitale, equivalga a liquidare il «carattere monetario» del valore e della valorizzazione. Effettivamente però, se il concetto di valore si dissolve nel concetto di denaro, se cioè ogni differenza tra questi concetti viene livellata, il problema scompare del tutto. Sintomatico è ora il modo in cui Heinrich affronta la teoria del credito.
Dapprima egli dichiara che «per Marx» il sistema creditizio «non era un mero orpello della produzione, una semplice sovrastruttura che funziona soprattutto come fattore di disturbo» (Heinrich 2003, p. 299). E chi avrebbe mai detto una cosa del genere? L’argomento proposto qui è completamente diverso. Che il credito sia parte integrante della valorizzazione, come dimostra Marx nel terzo libro del Capitale, è evidente. Specificare che non si tratta di un «mero orpello» o di un «fattore di disturbo», nel quadro dell’economia politica, è una banale ovvietà. Era stato piuttosto il campo antagonista, quello della critica riduttiva e piccolo-borghese del capitalismo, alla maniera di Proudhon o di Gesell, con la sua ossessione esclusiva per il capitale produttivo di interesse, a definirlo come un «fattore di disturbo» (esterno). Sebbene occasionalmente si trovi traccia di tutto ciò anche nella letteratura marxista «popolare», il marxismo, generalmente, perlomeno il marxismo del movimento operaio, fu sempre ostile a tali idee. Esso, al contrario, sottolineò affermativamente e in controtendenza il potenziale socializzatore del capitale finanziario, di cui lo Stato socialista si sarebbe fatto erede (lo si vede, notoriamente, nel caso di Hilferding).
Perché dunque questo sotterfugio da parte di Heinrich? Evidentemente lo scopo è quello di intorbidire e distorcere l’argomento addotto qui, che non c’entra proprio nulla con la concezione del credito come «fattore di disturbo» esterno. Invece il credito, sul piano dello sviluppo delle forze produttive dall’inizio del XX secolo, esprime una contraddizione interna della riproduzione capitalistica e della rispettiva dinamica. Superficialmente il fulcro del problema sembra essere la separazione sempre più smisurata tra acquisto e vendita, già posta in termini generali col denaro, laddove tale scissione concerne ora i costi preliminari e la produzione di plusvalore. Oggi il credito, ben lungi dall’essere un «fattore di disturbo» esterno, è una conditio sine qua non interna del processo di valorizzazione stesso. È per questo motivo che, come già illustrato, l’asse temporale della produzione di plusvalore si è spostato dal passato al futuro fino al distacco totale dalla produzione di valore reale del passato e del presente. Questa forbice, divaricatasi progressivamente nel corso della storia per le ragioni precedentemente addotte, segna una nuova dimensione della contraddizione intrinseca alla dinamica capitalistica. Il tentativo di Heinrich di ridefinire lo sviluppo teorico della contraddizione interna come una teoria del «fattore di disturbo» esterno rappresenta una chiara strategia difensiva volta ad eludere il ruolo di questa contraddizione sul livello del denaro e del credito.
E così, furbescamente, riferendosi ai critici keynesiani di Marx che gli rimproverano la teoria del credito come «fattore di disturbo» (in realtà piccolo-borghese), egli ribatte loro che tale teoria, in realtà, non è affatto di Marx, ma appartiene piuttosto a certi teorici radicali della crisi, che non si dovrebbe prendere troppo sul serio: «Alcuni autori di orientamento marxista, che sottolineano piuttosto gli aspetti non-monetari in Marx, concordano pienamente con questa teoria del credito come fattore di disturbo. Essi ritengono che l’espansione del credito sia già di per sé un sintomo di crisi» (ad es. si veda Kurz 1995)» (Heinrich 2003, p. 299 n.). Sebbene il saggio del 1995, contro cui Heinrich punta il dito, non contiene ancora la teoria sviluppata negli ultimi due capitoli, esso si muove già comunque in quella direzione. Da anni ormai Heinrich non si stanca di sollevare più e più volte la stessa accusa in testi differenti. È un mistero perché secondo lui l’elaborazione del potenziale di crisi insito nel credito coinciderebbe con l’enfatizzazione degli «aspetti non-monetari».
Inoltre egli confonde un aspetto della teoria della crisi per una «teoria del fattore di disturbo». Ma se il problema si esaurisse in un mero fattore di disturbo, allora per rilanciare la produzione basterebbe rimuoverlo (come pensano i critici dell’interesse, generalmente antisemiti). È vero però l’esatto contrario: è il credito che dilaziona temporaneamente il limite interno del modo di produzione capitalistico, combinandosi con il meccanismo storico di compensazione, oggi in via di deperimento.
Infine, scambia un mero processo ciclico con quella che è una irreversibile tendenza secolare di sviluppo, di cui neppure riconosce l’esistenza. Lascia indefinita la questione dell’espansione del credito o la giudica implicitamente come falsa. Nell’eterno saliscendi dei cicli congiunturali (Heinrich non ne conosce di altro genere), i crediti vengono concessi maggiormente in virtù del ciclo, nel caso di un boom, per poi regredire nuovamente in termini relativi durante la fase discendente. Questa dinamica in cui il credito si espande e poi successivamente si contrae, non rappresenta in sé un sintomo di crisi. In gioco qui c’è però qualcosa di completamente diverso e cioè l’espansione strutturale e secolare del credito, indipendente da una semplice modulazione ciclica. Tutto ciò è incomprensibile per il pensiero positivistico, astorico di Heinrich.
Pertanto non c’è da meravigliarsi che Heinrich creda ciecamente anche agli insulsi discorsi circa il «secolo del Pacifico», l’ascesa della Cina etc. e che gli riesca solo di osservare un trasferimento della produzione di plusvalore reale, apparentemente in continua crescita, su scala macroregionale. Questa idea è la base per le dichiarazioni, già citate, circa il «profitto senza fine» di un capitalismo che «sarebbe solo agli inizi» (vedi cap. XV). Una volta sbarazzatosi degli strumenti teorici necessari Heinrich si limita a scrutare la superficie del mercato mondiale e i «fatti» illusori dell’economia del deficit globale, senza individuare la struttura di mediazione desostanzializzata. E così gli risulta impossibile identificare la natura precaria di questa mobilitazione secondaria di capitale fisico e di forza-lavoro, senza fondamento nella sostanza del valore.
Nel complesso Heinrich, con la sua revisione di Marx, in ultima analisi, non fa che denunciare ogni devalorizzazione del capitale dovuta alla sua dinamica interna, che vada oltre una gradevole funzione «purificatrice», come un’impossibilità logica e pratica, non solo sul piano della teoria del valore ma anche su quello della teoria del denaro e del credito. E il fatto che Heinrich non affronti uno dei più imponenti fenomeni economici del Novecento, il processo secolare di inflazione, non depone certo a favore della sua perspicacia. Per Heinrich, a quanto sembra, esso sarebbe solo un elemento all’interno di una «storia degli eventi» esteriore, poco gratificante per un teorico. In questo modo svaniscono completamente le tracce della conseguenza logica e pratica della presunta «abolizione» della merce-denaro e della convertibilità in oro e l’intero processo può essere ridefinito come un sintomo del fatto che il capitalismo è in grado di affrontare i suoi problemi e di stabilizzarsi: «La merce-denaro si è rivelata un ostacolo aggirabile per la riproduzione capitalistica. Poiché oggi il sistema monetario non è più legato ad una merce-denaro, tale ostacolo è stato rimosso. Il sistema bancario privo di merce-denaro è in grado di reagire alle crisi in maniera più flessibile rispetto al passato» (Heinrich 2004, p. 161). Quod erat demonstrandum. Un incoraggiamento che, per quanto superfluo, stimolerà le banche centrali ad abbandonare qualsiasi inibizione nell’ambito della politica monetaria.
Anche se la Neuere Ortodoxie, come si è già detto in principio, appare, nel complesso, regressiva rispetto alla Neue Marxlektüre, se paragonata ai grossolani fraintendimenti nell’interpretazione che (specialmente) Michael Heinrich ci dà della teoria del denaro e del credito di Marx, essa contiene, sotto taluni aspetti, perfino un elemento di razionalità. Come si è già accennato (nel Cap. I), la lettura neo-ortodossa non mette in discussione la definizione della merce-denaro reale di Marx: «Per il solo fatto che il denaro è anche una “cosa di valore” [Wertding], oggettivazione di lavoro umano equivalente, esso può fungere da “specchio di valore” [Wertspiegel] per tutte le altre merci» (Knolle-Grothusen 2009, 120). Conseguentemente l’oro, per quanto solo «in linea di principio», dovrebbe essere «la merce-denaro ancora ai giorni nostri» (op. cit., 121). Come di consueto però tale posizione viene ridimensionata alla luce dei dogmi dell’individualismo ortodosso secondo cui ciò che il denaro esprime è fondamentalmente il valore della singola merce.
Questo però non è ancora tutto. Infatti, per quel che concerne i problemi relativi al denaro e al credito, che Marx non aveva esaminato, l’argomentazione si dimostra singolarmente impacciata, lasciando aperta, almeno implicitamente, la questione dell’oggettività degli sviluppi storici. Soprattutto nel caso dell’inflazione secolare, ancora sconosciuta ai tempi di Marx. Riguardo la contraddizione tra la sostanza di valore della merce-denaro e le sue funzioni nella forma desostanzializzata si afferma che questa «si manifesta nella moneta cartacea quando ne circola una quantità eccessiva rispetto alla merce-denaro teoricamente necessaria per la mediazione della circolazione stessa» (Knolle-Grothusen op. cit., p. 128, n.). Non c’è dubbio. Questa però è una semplice constatazione, che non spiega in alcun modo la ragione di questo fenomeno. È un processo oggettivo che si colloca sul livello delle categorie capitalistiche oppure è solo il frutto di un errore soggettivo?
La questione non si chiarisce neppure quando l’autore tenta di abbordare il fenomeno dell’inflazione in maniera apparentemente più concreta: «La causa consiste in un aumento della domanda solvibile, che non è a sua volta il risultato di vendite realmente effettuate, non emerge come l’esito della realizzazione del valore. In questo caso lo Stato genera domanda acquistando merci con le banconote che esso stesso stampa» (op. cit., p. 169; corsivo dell’autore). Giusto. Ma perché lo Stato fa ricorso a questo strumento? Per divertimento, in virtù di direttive politiche sconsiderate? Potrebbe anche farne a meno?
Ritroviamo la medesima esangue determinazione, solo definitoria, anche nei confronti del credito: «Il sistema creditizio scioglie i diritti su quote della ricchezza sociale dalla limitazione insita nella massa di merce-denaro socialmente disponibile, convertendoli in diritti su denaro futuro […] Tuttavia, come in ogni processo di autonomizzazione basato sull’unità contraddittoria della merce come valore d’uso e valore, tale autonomizzazione è solo relativa. Presto o tardi giunge il momento della resa dei conti» (op. cit., p. 87; corsivo dell’autore). Ma guarda, davvero? Non ce ne eravamo accorti, al pari dei guru dei mercati finanziari e dei ragazzi del consumismo post-moderno. Ma con questo, anche se la resa dei conti arriva e la contraddizione si palesa, ciò che resta inspiegato è proprio la concatenazione delle cause. Cosa sarebbe questo «diritto su denaro futuro»? Forse che l’autonomizzazione del credito nei confronti della produzione reale di valore è un fenomeno meramente soggettivo o contingente, fa parte dei cicli ordinari, si limita al livello «circolativo» e non ha per nulla a che vedere con la produzione di plusvalore? Oppure abbiamo a che fare con una dinamica nella sua fase di ascesa storica, tale da esigere una spiegazione in termini molto più fondamentali?
Nonostante l’opposizione «definitoria» sul terreno delle determinazioni di Marx (dogmatismo da un lato, revisione dall’altro), osservando le cose più da vicino, è possibile notare una certa consonanza tra la Neue Marxlektüre e la Neuere Orthodoxie nell’ambito della teoria del denaro e del credito: sia nell’uno che nell’altro caso la dinamica storica brilla per la sua assenza. La divergenza tra il livello empirico e quello concettuale fa sì che quest’ultimo, nella decurtata teorizzazione positivistica, vada incontro a una cristallizzazione astorica e che la storicità appaia solo sul piano empirico, nella forma di una storia degli eventi esteriore e insignificante, fatta di mere «fluttuazioni/stratificazioni» [Wechsellage]. E così la teoria del denaro e del credito risulta altrettanto superficiale della teoria della crisi e tra le due non si realizza alcuna mediazione sistematica. Per questa via non viene prodotto alcun nesso tra la crescita storica della composizione del capitale c/v, la caduta tendenziale del saggio del profitto, l’espansione storica del credito e il processo di inflazione secolare. Sul piano teorico invece ci si muove in un mondo economico ideale, come fanno i colleghi della teoria economica ufficiale, solo guarnito da una terminologia marxista, che si irrigidisce categorialmente in «definizioni» ed esteriorizza lo sviluppo o la dinamica in un «agire» soggettivamente determinato.
Del resto quanto influisca, in questa come in altre questioni, la costrizione al consenso e la pressione istituzionale dell’impresa accademica, ce lo rivela Stephan Krüger, nella summenzionata antologia di esponenti della Neuere Ortodoxie sulla teoria del denaro, nel momento in cui denuncia il fatto che oggi si debba «[…] rispondere quasi all’accusa di indulgere in opinioni stravaganti quando si intraprende il tentativo di studiare una relazione economicamente significativa tra le monete e l’oro come merce-denaro» (Krüger 2009, 218). Effettivamente però alcune crisi finanziarie e monetarie sarebbero già «[…] state risolte senza far ricorso in nessun caso all’oro come merce-denaro […] Alla diagnosi di una completa demonetizzazione del denaro […] nel frattempo non sembra più possibile obiettare seriamente nulla» (ibidem).
Invece di presentare una controprova teorica della crisi e della critica categoriale, Krüger (come Heinrich) si limita ad accettare i «fatti» del superficiale «complesso di accecamento» del capitalismo, inserendosi così nel discorso «serio» della gilda accademica. Egli elabora pertanto una «ipotesi di base» secondo cui «i fatti registrati come demonetizzazione forse sarebbero solo le forme fenomeniche di un’idealizzazione assai progredita della merce-denaro nella circolazione reale, identificabile attraverso un sviluppo ulteriore della categorie di Marx, senza respingere le determinazioni generali di merce, valore e denaro» (Krüger, op. cit., 219). In altre parole la demonetizzazione del denaro non rappresenta più un elemento di un processo graduale di crisi e di devalorizzazione sulla base della dinamica storica del capitale ma solo il «fatto» positivo di un’«idealizzazione assai progredita» della merce-denaro. Qui non è più necessario sviluppare ulteriormente la critica dell’economia politica perché sono le categorie dell’economia politica che devono adeguarsi a questa idealizzazione, senza liquidare, si intende, le definizioni fondamentali di Marx (buone ancora, plausibilmente, per qualche sermone dominicale a scopo autolegittimatorio).
E allora si comincia col dare un’interpretazione meno traumatica dell’inizio dell’inflazione secolare nelle economie di guerra. Su questo punto Krüger sostiene indubbiamente che «in relazione al finanziamento della guerra», la copertura aurea del denaro «dovette essere completamente soppressa» (Krüger, op. cit., p. 227). Le conseguenze di questo fatto vengono però negate o edulcorate: «Tuttavia le iperinflazioni che, per questa ragione, colpirono alcuni paesi non furono causate dalla sospensione della copertura aurea quanto piuttosto dalla creazione di semplici “segni del valore” [Wertzeichen] sotto forma di moneta cartacea statale sulla scia della concessione diretta di credito delle autorità monetarie allo Stato» (ibidem).
Questa tesi è uno svarione logico già solo sul piano linguistico. Affermare che la copertura aurea dovette essere soppressa per finanziare la guerra, che «per questa ragione» ebbero inizio processi di iperinflazione, i quali però, d’altro canto, non vennero causati dalla sospensione della copertura aurea, è intrinsecamente contraddittorio sul piano del nesso causale?. Si tratta in realtà del medesimo errore: effettivamente il sacrificio della copertura aurea fu il presupposto affinché le autorità monetarie potessero concedere direttamente crediti allo Stato sotto forma di semplici «segni di valore» come moneta cartacea. Dissolvere questa connessione in una giustapposizione di «non» e «ma» equivale allo stesso tempo a negarla di nuovo.
Dov’è quindi che vuole arrivare Krüger? Apparentemente la fine del legame con l’oro, per certi versi, si dissocia in un’impossibilità logica (per la coscienza teorica), da una parte, e in una fase reale di sviluppo, realmente praticabile (per il realismo politico-economico) dall’altra. Così Krüger può constatare che l’oro, in contraddizione con la sua totale demonetizzazione ufficiale, svolge un ruolo come «riserva valutaria nazionale» (op. cit., p. 231) presso le più importanti banche centrali. Questi tesori aurei delle banche centrali non avrebbero però «alcuna relazione attiva con il denaro circolante delle banche centrali», assumendo «solo la funzione di ultima ratio nel caso di un capovolgimento del sistema creditizio nel sistema monetario» (ibidem). Ciò sarebbe causato dalle «instabilità strutturali dei mercati finanziari» (ibidem) nel capitalismo.
Per questa via si perdono le tracce del processo di inflazione secolare mentre il potenziale di crisi che le è intrinseco, sotto forma di un processo generale di devalorizzazione, si riduce ad un’astratta «possibilità» astorica (capovolgimento del sistema creditizio nel sistema monetario), che si potrebbe scongiurare grazie a Dio o alla politica monetaria. Assieme all’oro come merce-denaro è tutta la base della critica dell’economia politica di Marx che viene convertita a dogma, irrilevante nella pratica, sulla sfondo di una «ultima ratio» cui non si farà mai ricorso, per potersi rivolgere poi, con un sospiro di sollievo, al pratico «idealismo» realista della «circolazione reale».
Pertanto, dopo qualche pagina della sua trattazione, il teorico del denaro «marxista» pseudo-ortodosso si trasforma in un esperto di politica monetaria, conscio delle proprie responsabilità. Come mera ultima ratio, privo di qualsivoglia relazione con l’emissione effettiva delle banche centrali, l’oro deve costituire solo lo sfondo passivo di «un sistema monetario rappresentativo basato sull’inconvertibilità» (op. cit., p. 255). Esso dunque se ne starà nascosto nelle casseforti come un tranquillante per la coscienza teorica dei marxisti o per il sonno pacifico degli investitori ma non sarà lecito praticamente a nessuno, né ai privati, né alle istituzioni, né agli Stati, di esigerlo come duro mezzo per la conservazione del valore. Si realizza così il miracolo di una convertibilità inconvertibile o di un idealismo materiale. Misure opportune in questo senso «favorirebbero una stabile dilazione del rapporto di rappresentazione tra l’oro e il denaro rappresentativo, in grado di sviluppare effetti assai benefici» (op. cit., p. 255). Sarebbe il caso che la quantità reale di oro restasse un segreto di Stato così da «dilazionare» a piacimento questo irreale «rapporto di rappresentazione»: «Finché l’inflazione di questo denaro rappresentativo nei confronti della merce-denaro resta sotto controllo», questa l’argomentazione, frutto della «coscienza infelice» del nostro apostolo della Nuova ortodossia marxista, ora genuinamente espressa nel gergo della teoria del denaro borghese e delle banche centrali, si potrebbe addirittura «tollerare un aumento moderato dei prezzi di mercato» (ibidem).
Qualche pagina prima, Krüger ha provato a sviluppare ulteriormente le categorie di Marx ma il suo intento, in realtà, era solo quello di ossequiare ancora per un po’ le loro reliquie; alla fine viene alla luce ciò che è veramente «importante», vale a dire «un dibattito sull’elaborazione ulteriore delle proposte che Keynes aveva formulato 65 anni or sono per l’organizzazione (!) di un sistema monetario internazionale, in grado di mitigare e tendenzialmente di escludere il pericolo di processi forieri di crisi» (op. cit., 259) e che possa essere, entro certi limiti, «politicamente gestibile» (ibidem). Krüger allude alla proposta di una valuta internazionale (all’illusione di un denaro mondiale immediato, che non sarebbe stato l’oro), chiamata «bancor», come unità di conto per i crediti e i debiti dei partecipanti al mercato mondiale. All’oro sarebbe spettata solo una funzione meramente simbolica, quella di misura del valore, «attraverso la denominazione del bancor» (ibidem) e come base fittizia di un idealismo generale del denaro. In altre parole il bancor avrebbe già in sé l’assurda «one-way convertibility» già menzionata, nella forma di un versamento di oro su base proporzionale da parte dei paesi partecipanti con l’esclusione però di ogni possibilità di restituzione o, più in generale, di riscatto.
Naturalmente ne sarebbe il presupposto, in primo luogo, l’inesistenza di una sostanza reale del valore e, secondariamente, l’inesistenza di una crisi reale da devalorizzazione. Affermando che «il ritorno al progetto della Clearing Union internazionale di Keynes» sarebbe già «radicale e rivoluzionario» (op. cit., 261), Krüger non è affatto «radicale e rivoluzionario», ma piuttosto un sedicente «medico al capezzale del capitalismo», pure privo della licenza. Del resto sembra questo, in generale, il destino di ogni ortodossia marxista, della nuova come della vecchia. L’insensatezza di una «organizzazione» del caos capitalistico è già fin troppo eloquente. Sacrificare la verità teorica al fine della cooperazione pratica con una terapia politico-monetaria rabberciata: sembra questa l’ultima parola della Nuova ortodossia post-modernizzata, non solo per ciò che riguarda la teoria del denaro e del credito.
Sia la negazione del processo di devalorizzazione da parte di Heinrich sul livello della (per lui inesistente) merce-denaro, sia la cura-placebo di Krüger al fine della presunta guarigione, sono già state visibilmente smentite sul piano empirico. Nella sua qualità di riserva del valore, l’oro, a dispetto di ogni comunicato e di ogni politica ufficiale, è già stato effettivamente rimonetizzato. L’esplosione storicamente senza precedenti del prezzo dell’oro – trattato come una materia prima e impossibile da convertire in valuta come denaro reale –non si può spiegare con l’aumento della sua domanda in termini di valore d’uso materiale ma solo con la sua qualità di denaro, ossia con il suo astratto valore d’uso sociale, che consiste nell’esprimere il valore di tutte le altre merci, e per giunta in forma sostanziale, che, in ultima analisi, è l’unica valida. Questo è stato riconosciuto indirettamente nel frattempo da tutte le più importanti banche centrali, che arrestano il deflusso delle loro riserve auree e si accingono in maniera neppure troppo sotterranea ad acquisire oculatamente nuove provviste d’oro. Questa rimonetazione pratica, non ufficiale, significa che tutte le monete prive di merce-denaro, senza eccezione alcuna, si stanno drammaticamente svalutando nei confronti dell’oro in quanto effettiva merce-denaro. La devalorizzazione relativa nei confronti dell’oro è il preludio della devalorizzazione assoluta del denaro desostanzializzato in una serie di avanzate inflazionistiche, anche se questo processo si manifesterà in forme altrettanto disomogenee del processo di devalorizzazione degli elementi non-monetari del capitale.
Naturalmente non si dovrebbe mai dimenticare che questa rimonetazione di fatto dell’oro non è la correzione di un errore di politica monetaria sulla strada del ritorno verso il vecchio standard aureo (come raccomandano in tutta serietà certi economisti teoricamente inconsistenti), bensì la manifestazione del limite interno assoluto del «modo di produzione basato sul valore» (Marx).
L’oro viene rimonetizzato, in maniera del tutto isolata, solo in quanto mezzo reale di conservazione del valore; nella sua specificità l’oro può «conservare il valore in quanto valore», solo per i singoli soggetti di mercato, mentre lo stesso valore si dissolve per i possessori di moneta cartacea o scritturale. Ma per quanto riguarda tutte le altre funzioni del denaro, indispensabili per la riproduzione capitalistica reale, l’oro non può davvero essere rimonetizzato. Un ritorno alla convertibilità generale in oro è illusoria in quanto le masse di denaro sono ormai da tempo prive di sostanza, e proprio a causa della medesima inflazione secolare che ha costretto all’abbandono della convertibilità aurea.
Il ritorno dello standard aureo significherebbe il ritorno al livello dei prezzi antecedente la Prima guerra mondiale. Ma questo è impossibile in quanto la somma di questi prezzi pre-inflazione andrebbe distribuita su di una quantità di merci talmente smisurata da rendere irrisorio il prezzo attuale di ogni singola merce. Lo si può esprimere anche nella forma-oro: siccome il valore reale contenuto in ogni singola merce nella concorrenza rappresenta ormai una quota addirittura omeopatica del valore sociale complessivo, anche la sua espressione sostanziale sulla base dell’oro si riduce inevitabilmente in maniera altrettanto drammatica. Se perfino il prezzo di un’automobile o di una lavatrice corrisponde a quantità microscopiche di oro, quello di un paio di mutande o di uno spillo sarebbe del tutto inesprimibile nella forma dell’oro. Sebbene la produttività delle miniere d’oro sia aumentata meno fortemente rispetto quella relativa alle «merci plebee», una merce-denaro reale come forma generale di circolazione per la socializzazione nella forma-merce risulta inconcepibile. La causa non è certo (oggi come nel passato) la transizione verso una riproduzione capitalistica priva di una merce-denaro sostanziale bensì la devalorizzazione storica del valore.
Così l’esplosione del prezzo dell’oro ha una dimensione estremamente speculativa, che tiene seriamente conto sul piano soggettivo, in modo tanto inconscio quanto affermativo, del processo reale di devalorizzazione, senza abolire la sua oggettività negativa. Anche se è probabile che i possessori di oro restino temporaneamente a galla nell’economia di crisi o che riescano persino a fare man bassa di beni, essi non potranno sfuggire al processo di disgregazione barbarica della società del valore. Alla fine la conservazione del valore sul piano soggettivo individuale non è poi una gran fortuna se esso diviene obsoleto su quello storico-sociale.
Per certi versi abbiamo a che fare ancora una volta con un «denaro senza valore», come nella proto-storia del denaro, che però ora è tale non perché sia un medium simbolico nel contesto di stabili rapporti di obbligazione reciproca organizzati su base religiosa ma a causa del collasso della sostanza capitalistica del valore, ossia del sistema, ormai completamente instabile, del «lavoro astratto». Gli ultimi tentativi di riprodurre le forme esaurite del feticcio del capitale all’interno di un rigido simbolismo religioso da parte delle correnti postmoderne del fascismo teocratico, in maniera tanto ossessiva quanto inconsapevole, sono a loro volta un elemento della tendenza del capitalismo verso l’autodistruzione. Su tale base è impossibile attaccare questa forma di relazione ormai obsoleta e allora è giocoforza mascherare la sua insostenibilità mediante assurdi rituali, disprezzo dell’individuo, repressione brutale e, soprattutto, un patriarcalismo arcaicizzante, che vorrebbe compensare i fenomeni di crisi attribuendo oneri riproduttivi sempre più gravosi alle donne, rivelandosi proprio per questa ragione, ad onta del suo travestimento religioso, specificatamente moderno e capitalistico. Viceversa, lo si deve ribadire: o gli uomini affrancano la loro socialità dalle forme della merce, del valore e del denaro – e solo con ciò dalla forma-capitale – oppure la «rovina comune» (Marx) dei soggetti della concorrenza sfocerà in un’epoca oscura della regressione storica del genere umano.
Robert Kurz (traduzione di Samuele Cerea)
—–
Bibliografia:
-Kurz, Robert, Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie, Berlino, 2012
-Heinrich, Michael, Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, Münster, 2003 (prima edizione 1999)
-Knapp, Georg Friedrich, Staatliche Theorie des Geldes, Monaco e Lipsia, 1905
-Knolle-Grothusen, Ansgar, Die Zusammenhang von Geldfunktionen und Geldformen in Kapital. In: Knolle-Grothusen/Krüger/Wolf, Geldware, Geld und Währung. Grundlagen zur Lösung des Problems der Geldware, Amburgo, 2009
-Krüger, Stephan, Geld und Geldware – Der Außen- und der Binnenwert des Geldes. In: Knolle-Grothusen/Krüger/Wolf, Geldware, Geld und Währung. Grundlagen zur Lösung des Problems der Geldware, Amburgo, 2009